|
"Custode"
delle storie e dei timbri della musica americana più onesta,
profonda e genuina. Non riesco a immaginare musicista che meriti
questo titolo più del californiano Dave Alvin. Né voglio
immaginare lettori spaventati dall'uso del sostantivo custode
("portinaio" o "bidello" suonavano male), nonostante ci sia
sempre chi storce il naso quando il rock'n'roll, e il suo portamento
semplice ed elementare (ma quante sfumature, quanti riflessi
possono balenare anche e soprattutto nella semplicità?), viene
contaminato da riferimenti appena un po' più "alti" rispetto
al medio analfabetismo imperversante nella critica musicale
italiana (a sua volta flagellata da falangi di volontari e bloggers
abituati a confondere analisi e opinione, nozionismo e capacità
di lettura), come se davvero bellezza, cultura e folclore non
avessero bisogno di custodi in grado di testimoniarne lo spirito
e i cambiamenti attraverso il tempo. Naturalmente il ruolo di
Dave Alvin nei panni di promotore delle radici musicali americane
non è - ovvio - quello di Giuseppe Parini precettore del piccolo
Gian Galeazzo in casa del Duca Serbelloni; prendetelo piuttosto
alla stregua di un William Last Heat-Moon in perenne viaggio
attraverso le "strade blu" (Strade Blu, Einaudi), o strade
secondarie, della provincia Americana non ancora inquinata dall'esplosione
orizzontale di shopping-malls e catene di cibo spazzatura per
raccoglierne racconti, volti, panorami, suoni e colori da tramandare
attraverso una canzone.
In questo senso, non si può che dar ragione a chi sostiene che
un grande artista gira sempre lo stesso film, dipinge solo lo
stesso quadro, scrive lo stesso libro o, appunto, canta soltanto
la stessa canzone: dalla Marie, Marie di trenta e rotti
anni fa, la ragazza intenta a "suonare la chitarra in modo così
triste / dal portico sul retro della sua casa" e insensibile
ai richiami del coetaneo che, sapendo quanto fossero solitarie
le "farmlands" (terre agricole) in cui entrambi vivevano, voleva
portarla ad ammirare "le luci sfavillanti del centro", Dave
Alvin non ha mai smesso di dar voce a chi una voce, sui grandi
media o nei guazzabugli delle classifiche pop, non l'aveva e
non l'avrebbe avuta, in questo modo - attraverso una radiografia
minima eppure partecipe e appassionata delle storie racchiuse
nei muri sbiaditi delle periferie, nel traffico soffocante delle
città di confine, nella solitudine dei deserti - rielaborando
il credo democratico di un Woody Guthrie con efficacia assai
maggiore rispetto ai tanti (troppi) folk-singer iper-ideologici
per i quali apocalisse e integrazione restano in fondo la stessa
cosa.
Per Dave Alvin, invece, l'apocalisse è una soltanto: quella
della memoria, quella dei nomi dimenticati nella luce crepuscolare
di una stazione di rifornimento o nei paesaggi sconosciuti di
una guerra lontana e distante. È stato così fin dall'inizio,
fin da quando, cioè, il giovane Dave, nato nel 1955 a Downey
(zona sud-est della Los Angeles County) e fin da piccolo appassionatosi
alle gesta di T-Bone Walker e Big Joe Turner, aveva in pratica
preso l'abitudine di impartire lezioni informali di roots-rock
un po' a tutti i membri del circuito punk della California,
prima facendo scoprire il blues a un Jeffrey Lee Pierce (Gun
Club) poco più che maggiorenne, poi prestando i servizi della
propria sei ai Flesh Eaters di Chris Desjardins e infine collaborando
con gli X di John Doe ed Exene Cervenka, per i quali avrebbe
sostituito il chitarrista dimissionario Billy Zoom e contribuito
alla creazione del progetto Knitters, in pratica l'alter-ego
country del gruppo madre. Senza dimenticare, è chiaro, l'epopea
dei Blasters, la formidabile macchina da guerra r'n'r
formata col fratello Phil che pratica ispirò, da sola o quasi,
tutta la rinascita del rock tradizionalista del periodo, di
fatto spianando la strada al successo di moltissimi artisti
intenti a recuperare una visione primigenia della musica country
e del rock'n'roll.
Nel 1985, all'indomani del capolavoro Hard Line, sembrò
davvero che i Blasters stessero per diventare i più credibili
eredi del gesto rockista e proletario dei Creedence Clearwater
Revival, e invece le solite, insanabili divergenze tra i fratelli
Alvin mandarono tutto a monte. Entrambi esordirono da solisti
(e gli album di Phil, sia l'incompreso Un Sung Stories
['86], elegante frullato di jazz, blues e gospel confezionato
col supporto della Dirty Dozen Brass Band e dell'Arkestra di
Sun Ra, sia il misconosciuto County Fair 2000 ['94],
ottimo esempio di "Americana" in anticipo sui tempi, andrebbero
riscoperti), ma tra i due, a dare l'impressione di un radioso
avvenire davanti a sé fu da subito fu Dave, il cantautore del
gruppo, appena gratificato di un contratto nuovo di zecca da
parte della potente Columbia. Anche stavolta, però, le cose
non andarono come previsto: Romeo's Escape, il
debutto di Dave da titolare (intitolato chissà perché Every
Night About This Time nell'edizione europea targata Demon),
pur supportato da buone recensioni, non ottenne un risultato
commerciale in linea con le aspettative dell'editore e Dave
si ritrovò in men che non si dica senza uno straccio di etichetta.
Per sgombrare la mente da brutti pensieri e preoccupanti prospettive
professionali, Alvin si concesse un tour a fianco di due vecchi
amici, Mojo Nixon (adorabile pazzoide psychobilly) e Country
Dick Montana (ex cantante e batterista dei Beat Farmers, prematuramente
scomparso nel 1995): col nome di Pleasure Barons e con lo slogan
"un varietà in stile Las Vegas da parte una compagnia a cui
non verrebbe mai chiesto di esibirsi a Vegas", i tre girarono
in lungo e in largo gli stati del Sud al ritmo bislacco di medley
da Tom Jones, classici blues elettrici di Bo Diddley e rhytm'n'blues
mutuati da Joe South (Games People Play, terrificante showcase
delle abilità del Dave Alvin chitarrista). Dopo un secondo tour
arrivò persino un album, il delizioso Live In Las Vegas
('93), pubblicato dalla Hightone, che dal '91 al 2004 fu per
Alvin una specie di seconda casa dove sfogare la propria predilezione
per alcuni grandi del passato: difatti ottenne carta bianca
per allestire un pionieristico tributo a Merle Haggard (Tulare
Dust, '94) e si tolse persino lo sfizio di registrare un
disco, peraltro gradevolissimo, al fianco di Sonny Burgess,
stagionata leggenda rockabilly dell'Arkansas (Tennessee Border,
'92).
Qualche anno dopo, King Of California ('94), stupenda
raccolta unplugged destinata a costituire un precedente nella
carriera dell'artista, divenne il trampolino di lancio verso
futuri successi (compreso il Grammy, ottenuto nella categoria
Best Contemporary Folk Album, per Public Domain: Songs
From The Wild Land ['00], scarna e antispettacolare
collezione di traditionals d'impronta folk, blues e country).
Attraversati gli anni '90 con splendida maturità folkie (e con
qualche disco dal vivo buono a far ruggire i motori del rock'n'roll
come ai tempi dei Blasters), nel decennio successivo, contrassegnato
dal lutto per il precoce trapasso dell'amico Chris Gaffney (morto
appena cinquantasettenne, nel 2008, a causa di un cancro al
fegato: un anno dopo, Dave gli dedicherà, orchestrandolo, suonandovi
dappertutto e provvedendo a radunare tutti i partecipanti, il
magnifico tributo Man Of Somebody's Dreams) si è dedicato
con impegno e costanza (di risultati) all'arte difficile del
rinnovamento. È importante, a questo punto, sottolineare un
elemento essenziale del percorso di Dave Alvin: mi riferisco
alla tendenza, non per caso ricorrente, a scontornare in profondità
le proprie composizioni (spesso riproposte tramite arrangiamenti
diversi) e a cimentarsi con la scrittura altrui, fino ad avere
in carnet due dischi interamente composti di brani non autografi.
Tendenza, questa, non ascrivibile a una fantomatica povertà
d'ispirazione, bensì al mai sopito desiderio, tipico del fan
ammirato, di confrontarsi con le proprie passioni e i propri
referenti stilistici allo scopo di amplificarne il valore, evidenziarne
la virtù, sottoporne a manutenzione il ricordo. Comunque la
si veda rispetto ai risultati, secondo chi vi scrive di rado
al di sotto di livelli standard d'eccellenza, l'obiettivo di
Dave Alvin può dirsi raggiunto.
È anche merito suo, e di tutti i tradizionalisti come lui, se
oggi la memoria dei suoni più antichi viene sottoposta a indagini
analitiche e processi di conservazione, se il mercato non è
in mano a un pugno di multinazionali incompetenti e arraffone,
se il cuore profondo dell'America può ancora contare su artisti
in grado di raccontarne non solo grettezza e squallore ma sogni,
seconde possibilità, speranze piccole e grandi (tutte raccontate
con grande affetto nelle raccolte di poesie e racconti. È anche
grazie a lui se, nella vastità irraggiungibile della heartland
americana, tutte le donne col cuore spezzato (quelle che si
concedono "ogni notte alla stessa ora" perché "le facce non
contano granché / a luci spente", quelle a cui "non c'è nulla
da dire quando te ne vai / nessun bisogno di lunghi addii" perché
non sentiranno la tua, di mancanza, ma di un amante sparito
molto tempo prima), tutte le ragazze scappate da casa (magari
da un padre ubriaco e manesco, e ora ridotte "a ballare sui
tavoli / per pagare l'affitto, riuscire a cavarsela / e forse
restare pulite", pronte a un appuntamento in un bar di Austin
e a sperare che lui, l'uomo dell'appuntamento, "non sia così
schifoso", almeno non questa volta), tutti gli amori di un tempo
rimasti in qualche dimessa cittadina dei margini a rimpiangere
le opportunità perdute ("non posso dirti molto sulla nostra
vecchia città / tutto cambia ma non c'è nulla di nuovo / (…)
/ io faccio sempre lo stesso lavoro / vivo ancora con mia madre
/ da quando il vecchio se n'è andato / lasciarla è diventato
ancora più difficile" scrivono, in lunghe lettere che non saranno
mai spedite), tutte le notti troppo lunghe e le madri abbandonate
(le stesse che ogni sera, poco dopo la mezzanotte, dedicano
un brano al loro uomo scomparso "provando a ricordare il calore
del suo tocco") hanno trovato una radio sempre accesa, pronta
a trasmettere le loro illusioni e la loro resistenza quotidiana
incartandole in una canzone. È la radio sulla quale tutti noi,
un giorno, ci siamo sintonizzati, senza più cambiare stazione.
È la radio del confine.
|
| |
|  Blackjack David [Hightone, 1998]
Blackjack David [Hightone, 1998]
 Secondo
pannello di un dittico con pochi eguali nella storia recente del rock delle radici,
Blackjack David fa ripartire la scrittura di Dave Alvin da altezze
vertiginose. Il team di musicisti è lo stesso di King Of California (in più c'è
Dillon O'Brian alle prese con fisarmonica e armonio), ma le canzoni, questa volta,
sono quasi tutta farina del sacco di Alvin, mai così sicuro, appuntito e preciso
nell'accumulare dettagli narrativi degni di un John Hiatt o di un Raymond Carver.
Dal border patrolman inorridito di fronte al ritrovamento di una clandestina già
cadavere (e comunque costretto a rimpatriarne il marito) in una California
Snow scritta a quattro mani con Tom Russell, fino al lento dissolversi
di una relazione descritto in Evening Blues
o al reduce ossessionato dal ricordo un commilitone abbandonato nella giungla
del Vietnam (1968, cointestata a Chris Gaffney), Blackjack David contiene alcune
delle migliori storie mai tratteggiate dall'autore, tutte confezionate in un suono
di elegantissima fattura elettroacustica. Anche lo schema della track-list, con
un sapiente intercalare di folk ambientale, scossoni roots e blues spettrali,
riprende quasi alla lettera quello del predecessore. Registrati nei Media Vortex
Studios di Burbank, California, tra il febbraio e il marzo del '98, il blues spagnoleggiante
della title-track, il mid-tempo roots-rock di Abilene,
la gracile tristezza folkie di From A Kitchen Table
(accompagnata con discrezione dal clarinetto e dall'organo di Doug Wieselman),
la solenne murder-ballad di Mary Brown o lo
swingato country & western di Laurel Lynn
(nelle parole di Alvin, "Howlin' Wolf incontra un fisarmonicista cajun e la band
di Roy Acuff") inquadrano il sobrio perimetro di stile di un disco tanto essenziale
quanto incisivo. La conclusione dell'album, affidata al rarefatto intreccio di
steel à la Daniel Lanois dell'evocativa Tall Trees,
apoteosi visionaria di dark-folk da qualche parte tra Blind Willie Johnson e Twin
Peaks, sintetizza in modo perfetto il suono al tempo stesso ruvido ed elegante
di un album i cui rintocchi assomigliano al lento schiudersi di una primavera
tardiva, foriera di un paesaggio dove i timidi raggi del primo sole ancora non
hanno disciolto il manto di neve appoggiato su case, strade e palazzi. "Ho sentito
dire che ti sei sposata / anche se avevi giurato che non l'avresti mai fatto /
Immagino tu abbia avuto dei bambini tuoi, ora, / gli racconti mai del vecchio
vicinato? / Come quella volta in cui rubammo la macchina di tuo padre / e guidammo
tutta la notte lungo la Imperial Highway / Tu continuavi a ripetere che dovevamo
tornare indietro, / io ti rispondevo che scappare non era poi così difficile",
canta Alvin nelle diminuite di From A Kitchen Table, e da quel tavolo, da questo
disco, si ha la sensazione di poter osservare un mondo. Secondo
pannello di un dittico con pochi eguali nella storia recente del rock delle radici,
Blackjack David fa ripartire la scrittura di Dave Alvin da altezze
vertiginose. Il team di musicisti è lo stesso di King Of California (in più c'è
Dillon O'Brian alle prese con fisarmonica e armonio), ma le canzoni, questa volta,
sono quasi tutta farina del sacco di Alvin, mai così sicuro, appuntito e preciso
nell'accumulare dettagli narrativi degni di un John Hiatt o di un Raymond Carver.
Dal border patrolman inorridito di fronte al ritrovamento di una clandestina già
cadavere (e comunque costretto a rimpatriarne il marito) in una California
Snow scritta a quattro mani con Tom Russell, fino al lento dissolversi
di una relazione descritto in Evening Blues
o al reduce ossessionato dal ricordo un commilitone abbandonato nella giungla
del Vietnam (1968, cointestata a Chris Gaffney), Blackjack David contiene alcune
delle migliori storie mai tratteggiate dall'autore, tutte confezionate in un suono
di elegantissima fattura elettroacustica. Anche lo schema della track-list, con
un sapiente intercalare di folk ambientale, scossoni roots e blues spettrali,
riprende quasi alla lettera quello del predecessore. Registrati nei Media Vortex
Studios di Burbank, California, tra il febbraio e il marzo del '98, il blues spagnoleggiante
della title-track, il mid-tempo roots-rock di Abilene,
la gracile tristezza folkie di From A Kitchen Table
(accompagnata con discrezione dal clarinetto e dall'organo di Doug Wieselman),
la solenne murder-ballad di Mary Brown o lo
swingato country & western di Laurel Lynn
(nelle parole di Alvin, "Howlin' Wolf incontra un fisarmonicista cajun e la band
di Roy Acuff") inquadrano il sobrio perimetro di stile di un disco tanto essenziale
quanto incisivo. La conclusione dell'album, affidata al rarefatto intreccio di
steel à la Daniel Lanois dell'evocativa Tall Trees,
apoteosi visionaria di dark-folk da qualche parte tra Blind Willie Johnson e Twin
Peaks, sintetizza in modo perfetto il suono al tempo stesso ruvido ed elegante
di un album i cui rintocchi assomigliano al lento schiudersi di una primavera
tardiva, foriera di un paesaggio dove i timidi raggi del primo sole ancora non
hanno disciolto il manto di neve appoggiato su case, strade e palazzi. "Ho sentito
dire che ti sei sposata / anche se avevi giurato che non l'avresti mai fatto /
Immagino tu abbia avuto dei bambini tuoi, ora, / gli racconti mai del vecchio
vicinato? / Come quella volta in cui rubammo la macchina di tuo padre / e guidammo
tutta la notte lungo la Imperial Highway / Tu continuavi a ripetere che dovevamo
tornare indietro, / io ti rispondevo che scappare non era poi così difficile",
canta Alvin nelle diminuite di From A Kitchen Table, e da quel tavolo, da questo
disco, si ha la sensazione di poter osservare un mondo.
 West of the West [Yep Roc, 2007]
West of the West [Yep Roc, 2007]
 Il
fantasma dell'inverno di Blackjack David è scomparso. Al suo posto, ecco la mitezza
primaverile di una California bagnata dal sole, dall'abbraccio con l'asfalto,
dalle onde flessuose dell'oceano Pacifico, dall'ombra remota delle montagne del
vicino Oregon. West Of The West è il personale tributo dell'autore
alle canzoni di altri cantautori (dal Jackson Browne di Redneck
Friend al Tom Waits di Blind Love,
dai Los Lobos di Down On The Riverbed al Richard
Berry di I Am Bewildered), tutti accomunati
dal fatto di provenire dal cosiddetto "Sunshine State", e la conferma di come,
negli ultimi vent'anni, il Dave Alvin acustico (o semiacustico) abbia di
gran lunga superato, in fantasia e raffinatezza, la controparte elettrica. Naturalmente,
nemmeno qui latitano le eccezioni alla regola: il capolavoro del disco, una Loser
presa in prestito alle fantasticherie psych di Jerry Garcia e Robert Hunter (stava
sul debutto del barbuto chitarrista, l'omonimo Garcia del '72), trasforma il suono
dilatato e visionario dell'originale in un tagliente noir elettrico sferzato dalle
rasoiate di tre diverse chitarre, mentre il doo-wop celestiale della Surfer
Girl originaria (proprietà dei Beach Boys) regala l'occasione, grazie
alle armonie vocali dei Calvanes, per redigere un omaggio all'Elvis Presley formato
gospel delle registrazioni con i Jordanaires. Ma il succo dell'album resta nei
morbidi intrecci tra sei corde acustiche, organo, pianoforte e percussioni di
California Bloodlines (John Stewart) o Tramps
And Hawkers (Jim Ringer), due riletture che hanno il pregio di individuare
tutta la personalità dello stile di Alvin, imbattibile nel cesello di ballate
ingentilite dalle luci del tramonto, senza snaturare la lettera dei prototipi.
Incantevoli sono anche la malinconia western di una Kern
River (Merle Haggard) tutta pedal-steel, violino e mandolino, la nostalgica
tenerezza country-rock di una Here In California
(Kate Wolf) attraversata da slide e harmonies da manualistica del genere, il country-blues
per armonica, National Steel e pianoforte di Don't Look
Now (dai Creedence di Willy & The Poorboys). Giustissima, infine, l'inclusione
di Between The Cracks, brano scritto a quattro
mani da Dave Alvin e Tom Russell (la pubblicò per primo Alvin, su Museum Of Heart,
ma questa versione è più simile alla lettura russelliana reperibile nell'ottimo
The Rose Of The San Joaquin ['95]) su un pugile ("Kid Hey Zeus") sparito a Los
Angeles e sulla sua donna che continua ad aspettarlo, lavorando duro nei campi
della Valle di San Joaquin: un pezzo magnifico, colonna sonora ideale di un film
neanche tanto immaginario (Città Amara di John Huston andrebbe benissimo) ambientato
tra il Messico e la California, che dimostra, casomai ce ne fosse stato bisogno,
lo status di classico ormai raggiunto dal songwriting dell'artista. Il
fantasma dell'inverno di Blackjack David è scomparso. Al suo posto, ecco la mitezza
primaverile di una California bagnata dal sole, dall'abbraccio con l'asfalto,
dalle onde flessuose dell'oceano Pacifico, dall'ombra remota delle montagne del
vicino Oregon. West Of The West è il personale tributo dell'autore
alle canzoni di altri cantautori (dal Jackson Browne di Redneck
Friend al Tom Waits di Blind Love,
dai Los Lobos di Down On The Riverbed al Richard
Berry di I Am Bewildered), tutti accomunati
dal fatto di provenire dal cosiddetto "Sunshine State", e la conferma di come,
negli ultimi vent'anni, il Dave Alvin acustico (o semiacustico) abbia di
gran lunga superato, in fantasia e raffinatezza, la controparte elettrica. Naturalmente,
nemmeno qui latitano le eccezioni alla regola: il capolavoro del disco, una Loser
presa in prestito alle fantasticherie psych di Jerry Garcia e Robert Hunter (stava
sul debutto del barbuto chitarrista, l'omonimo Garcia del '72), trasforma il suono
dilatato e visionario dell'originale in un tagliente noir elettrico sferzato dalle
rasoiate di tre diverse chitarre, mentre il doo-wop celestiale della Surfer
Girl originaria (proprietà dei Beach Boys) regala l'occasione, grazie
alle armonie vocali dei Calvanes, per redigere un omaggio all'Elvis Presley formato
gospel delle registrazioni con i Jordanaires. Ma il succo dell'album resta nei
morbidi intrecci tra sei corde acustiche, organo, pianoforte e percussioni di
California Bloodlines (John Stewart) o Tramps
And Hawkers (Jim Ringer), due riletture che hanno il pregio di individuare
tutta la personalità dello stile di Alvin, imbattibile nel cesello di ballate
ingentilite dalle luci del tramonto, senza snaturare la lettera dei prototipi.
Incantevoli sono anche la malinconia western di una Kern
River (Merle Haggard) tutta pedal-steel, violino e mandolino, la nostalgica
tenerezza country-rock di una Here In California
(Kate Wolf) attraversata da slide e harmonies da manualistica del genere, il country-blues
per armonica, National Steel e pianoforte di Don't Look
Now (dai Creedence di Willy & The Poorboys). Giustissima, infine, l'inclusione
di Between The Cracks, brano scritto a quattro
mani da Dave Alvin e Tom Russell (la pubblicò per primo Alvin, su Museum Of Heart,
ma questa versione è più simile alla lettura russelliana reperibile nell'ottimo
The Rose Of The San Joaquin ['95]) su un pugile ("Kid Hey Zeus") sparito a Los
Angeles e sulla sua donna che continua ad aspettarlo, lavorando duro nei campi
della Valle di San Joaquin: un pezzo magnifico, colonna sonora ideale di un film
neanche tanto immaginario (Città Amara di John Huston andrebbe benissimo) ambientato
tra il Messico e la California, che dimostra, casomai ce ne fosse stato bisogno,
lo status di classico ormai raggiunto dal songwriting dell'artista.
 Dave Alvin & The Guilty Women [Yep Roc, 2009]
Dave Alvin & The Guilty Women [Yep Roc, 2009]
 Quasi
nessuno ha colto la grazia enorme, la bellezza corale, la spontaneità di questo
album. Meglio così, forse: significa che in giro ci sono tanti ascoltatori con
una sorpresa che li attende dietro l'angolo. Dave Alvin & The Guilty Women,
progetto all-female canonizzato da Alvin dopo un'estemporanea esibizione del neonato
gruppo all'Hardly Strictly Bluegrass Festival di San Francisco in cui il nostro,
ipse dixit, si era limitato a radunare musiciste da sempre apprezzate, dimostra
in modo ancora una volta probante quante siano le possibilità di svecchiare una
tradizione, nonché un genere di solito appaltato alla metà maschile del cielo,
senza tradirne lo spirito ma, anzi, ringiovanendolo con pochi gesti schietti e
genuini. Non so se la freschezza del disco vada imputata a Christy McWilson (voce
solista), Cindy Cashdollar (chitarre steel, National, Weissenborn e resofoniche
assortite un fenomeno), Nina Gerber (sei corde), Laurie Lewis (mandolino), Amy
Farris (viola e violino), Sarah Brown (basso) e Lisa Pankratz (batteria), senza
dimenticare Marcia Ball (pianoforte) e Suzy Thompson (fisarmonica) in quanto donne;
so, tuttavia, che l'atmosfera sororale, di confidenza e intimità, diffusa lungo
tutte e dodici le canzoni dell'album non potrebbe prescindere dalla loro particolare
visione della materia roots, qui affrontata con una densità di sfumature e una
ricchezza di suoni spesso impossibile a reperirsi nei lavori di colleghi sovente
più interessati a manifestarne la forza virile ed epidermica (e, di riflesso,
poco attenti al fascino delle mezze tinte o al magnetismo delle allusioni). Ecco,
quindi, Marie, Marie nella sua versione più
bella di sempre, festosa e trascinante come un ballo cajun offerto alla luna svettante
sulla costa acadienne del Québec, ecco i velenosi suffumigi bluesy della crepitante
California's Burning, il folk-rock etereo
e malinconico di Downey Girl, l'hillbilly
appalachiano di una Weight Of The World che
sembra Dock Boggs travolto da Jerry Lee Lewis. Il commovente folk operistico di
Anyway, l'accorato country-gospel di Potter's
Field e la magnifica ballata rootsy These
Thimes We're Living In (un gioiello dimenticato di Kate Wolf) trovano
poi degni contraltari nel focoso rhytm'n'blues di Boss
Of The Blues (ennesimo peana di Alvin all'adorato Big Joe Turner),
nell'honky-tonk di Nana And Jimi e nel rock'n'roots
elettroacustico di River Under The Road e
Don't Make Promises (quest'ultima un vero
e proprio showcase di virtuosismi sugli strumenti a corda), fino alla chiosa deliziosa
di una Que Sera, Sera (proprio quella cantata
da Doris Day nell'hitchcockiano Uomo Che Sapeva Troppo ['56]), posta in coda all'album
per suggerire come tempo e speranze, in fondo, guariscano ogni ferita. Quasi ogni
ferita: Amy Farris, la piccola violinista rossocrinita che nel booklet
di Dave Alvin & The Guilty Women nasconde il proprio volto dietro il corpo dello
strumento, è stata ritrovata nella sua casa di L.A., priva di vita, pochi mesi
dopo la pubblicazione dell'album, vittima di un suicidio - questa la spietata
diagnosi delle autorità inquirenti - per intossicazione da antidepressivi. Quasi
nessuno ha colto la grazia enorme, la bellezza corale, la spontaneità di questo
album. Meglio così, forse: significa che in giro ci sono tanti ascoltatori con
una sorpresa che li attende dietro l'angolo. Dave Alvin & The Guilty Women,
progetto all-female canonizzato da Alvin dopo un'estemporanea esibizione del neonato
gruppo all'Hardly Strictly Bluegrass Festival di San Francisco in cui il nostro,
ipse dixit, si era limitato a radunare musiciste da sempre apprezzate, dimostra
in modo ancora una volta probante quante siano le possibilità di svecchiare una
tradizione, nonché un genere di solito appaltato alla metà maschile del cielo,
senza tradirne lo spirito ma, anzi, ringiovanendolo con pochi gesti schietti e
genuini. Non so se la freschezza del disco vada imputata a Christy McWilson (voce
solista), Cindy Cashdollar (chitarre steel, National, Weissenborn e resofoniche
assortite un fenomeno), Nina Gerber (sei corde), Laurie Lewis (mandolino), Amy
Farris (viola e violino), Sarah Brown (basso) e Lisa Pankratz (batteria), senza
dimenticare Marcia Ball (pianoforte) e Suzy Thompson (fisarmonica) in quanto donne;
so, tuttavia, che l'atmosfera sororale, di confidenza e intimità, diffusa lungo
tutte e dodici le canzoni dell'album non potrebbe prescindere dalla loro particolare
visione della materia roots, qui affrontata con una densità di sfumature e una
ricchezza di suoni spesso impossibile a reperirsi nei lavori di colleghi sovente
più interessati a manifestarne la forza virile ed epidermica (e, di riflesso,
poco attenti al fascino delle mezze tinte o al magnetismo delle allusioni). Ecco,
quindi, Marie, Marie nella sua versione più
bella di sempre, festosa e trascinante come un ballo cajun offerto alla luna svettante
sulla costa acadienne del Québec, ecco i velenosi suffumigi bluesy della crepitante
California's Burning, il folk-rock etereo
e malinconico di Downey Girl, l'hillbilly
appalachiano di una Weight Of The World che
sembra Dock Boggs travolto da Jerry Lee Lewis. Il commovente folk operistico di
Anyway, l'accorato country-gospel di Potter's
Field e la magnifica ballata rootsy These
Thimes We're Living In (un gioiello dimenticato di Kate Wolf) trovano
poi degni contraltari nel focoso rhytm'n'blues di Boss
Of The Blues (ennesimo peana di Alvin all'adorato Big Joe Turner),
nell'honky-tonk di Nana And Jimi e nel rock'n'roots
elettroacustico di River Under The Road e
Don't Make Promises (quest'ultima un vero
e proprio showcase di virtuosismi sugli strumenti a corda), fino alla chiosa deliziosa
di una Que Sera, Sera (proprio quella cantata
da Doris Day nell'hitchcockiano Uomo Che Sapeva Troppo ['56]), posta in coda all'album
per suggerire come tempo e speranze, in fondo, guariscano ogni ferita. Quasi ogni
ferita: Amy Farris, la piccola violinista rossocrinita che nel booklet
di Dave Alvin & The Guilty Women nasconde il proprio volto dietro il corpo dello
strumento, è stata ritrovata nella sua casa di L.A., priva di vita, pochi mesi
dopo la pubblicazione dell'album, vittima di un suicidio - questa la spietata
diagnosi delle autorità inquirenti - per intossicazione da antidepressivi.
|
| |
| | | |
|
 Romeo's Escape [Demon, 1987]
Romeo's Escape [Demon, 1987]
Blue Blvd.
[Hightone, 1991]
Museum
Of Heart [Hightone, 1993]
 Congedata
l'esperienza dei Blasters, Dave Alvin riappare nei negozi di dischi con
un ottimo lavoro solista che ha il solo difetto di non aggiungere quasi nulla
alle migliori intuizioni del vecchio gruppo (dal cui repertorio, peraltro, preleva
ben quattro canzoni). Romeo's Escape, aiutato dalla spigolosa produzione
stonesiana di Steve Berlin, suona dunque come un buon punto della situazione,
ma dal punto di vista della confezione non dice molto di più rispetto a quanto
già espresso, con ben altri colori e ben altra energia, tra i solchi di Hard Line,
l'indimenticabile canto del cigno della prima band del nostro. Il solitario disincanto
dell'asciutta Brother (On The Line) (forse
un'invocazione al fratello Phil), il "tiro" springsteeniano di I
Wish It Was Saturday Night e la grinta rootsy di Far
Away funzionano in modo impeccabile, eppure resta l'impressione di
trovarsi di fronte a un riassunto piuttosto che a un paradigma su cui scommettere
per il futuro. Il problema, evidenziato anche nel successivo Blue Blvd.,
sta in una band di secondo piano (complicazione del resto sofferta dal nostro
fino all'incontro con Greg Leisz) e in arrangiamenti che, pur volendo catturare
la magia di alcune grandi registrazioni del passato, finiscono per risultare un
po' vecchiotti e paludati. Il secondo album di Alvin, poi, nonostante diverse
tracce di ottima caratura (lo scuro folk-blues di Dry
River, il devastante rockabilly chitarristico di Haley's
Comet e Wanda And Duane, l'epico
populismo roots di Andersonville) risente
anche di un'invadente batteria fuori tempo massimo, per fortuna scomparsa, o meglio
ammorbidita, in Museum Of Heart, primo passo verso la definizione
del sound Americana dell'artista e tuttavia lavoro ancora incerto, zoppicante.
I suoi brani migliori (Thirty Dollar Room
e la title-track) verranno in seguito totalmente stravolti, il resto verrà dimenticato
piuttosto in fretta. Congedata
l'esperienza dei Blasters, Dave Alvin riappare nei negozi di dischi con
un ottimo lavoro solista che ha il solo difetto di non aggiungere quasi nulla
alle migliori intuizioni del vecchio gruppo (dal cui repertorio, peraltro, preleva
ben quattro canzoni). Romeo's Escape, aiutato dalla spigolosa produzione
stonesiana di Steve Berlin, suona dunque come un buon punto della situazione,
ma dal punto di vista della confezione non dice molto di più rispetto a quanto
già espresso, con ben altri colori e ben altra energia, tra i solchi di Hard Line,
l'indimenticabile canto del cigno della prima band del nostro. Il solitario disincanto
dell'asciutta Brother (On The Line) (forse
un'invocazione al fratello Phil), il "tiro" springsteeniano di I
Wish It Was Saturday Night e la grinta rootsy di Far
Away funzionano in modo impeccabile, eppure resta l'impressione di
trovarsi di fronte a un riassunto piuttosto che a un paradigma su cui scommettere
per il futuro. Il problema, evidenziato anche nel successivo Blue Blvd.,
sta in una band di secondo piano (complicazione del resto sofferta dal nostro
fino all'incontro con Greg Leisz) e in arrangiamenti che, pur volendo catturare
la magia di alcune grandi registrazioni del passato, finiscono per risultare un
po' vecchiotti e paludati. Il secondo album di Alvin, poi, nonostante diverse
tracce di ottima caratura (lo scuro folk-blues di Dry
River, il devastante rockabilly chitarristico di Haley's
Comet e Wanda And Duane, l'epico
populismo roots di Andersonville) risente
anche di un'invadente batteria fuori tempo massimo, per fortuna scomparsa, o meglio
ammorbidita, in Museum Of Heart, primo passo verso la definizione
del sound Americana dell'artista e tuttavia lavoro ancora incerto, zoppicante.
I suoi brani migliori (Thirty Dollar Room
e la title-track) verranno in seguito totalmente stravolti, il resto verrà dimenticato
piuttosto in fretta.
 Public Domain [Hightone, 2000]
Public Domain [Hightone, 2000]
 O
di come certi dischi non andrebbero mai rispolverati, giacché vi sono occasioni
in cui il ricordo, pur deformato da altri fattori, è molto meglio della verifica.
Avevo un'opinione altissima di questo album, raccolta di vecchie canzoni folk
("spiriti che appartengono a ciascuno di noi", dice Alvin) tra l'altro contrassegnata
da un sorprendente successo anche al di fuori della nicchia del genere, finché
non l'ho ripreso in mano per la presente retrospettiva: con mia somma sorpresa,
mi sono trovato di fronte a 15 canzoni soporifere e sorpassate, a una galleria
di anticaglie folk dove, forse per la prima ed unica volta nel corso di un'intera
carriera, l'istintivo slancio di Dave Alvin nei confronti della tradizione
musicale del suo paese sembra rispondere non tanto a un desiderio di traduzione
creativa, bensì a una logica di conservazione museale e inutilmente ampollosa.
Il punto, qui, non è salvare questa o quell'altra interpretazione (il country-blues
di Maggie Campbell e Walk
Right In, il rockaccio furioso di Don't Let
Your Deal Go Down o l'evocativo passo folkie di Sign
Of Judgment passano l'esame senza alcun intoppo); il punto è che il
pur volenteroso ventaglio folk-rock aperto in Shenandoah
scompare in un batter d'occhio se paragonato, per dire, alla rilettura effettuata
da Bill Frisell nel quasi coevo Good Dog, Happy Man ('99) (tra parentesi molto
più affine al suono acustico dell'ultimo Alvin), e che la narcotica versione di
Texas Rangers qui contenuta la potremmo forse
accettare, fra uno sbadiglio e l'altro, in un disco didattico di Michael Martin
Murphey, o nelle fantasie di chi ancora gioca ai soldatini, non certo in un lavoro
di Dave Alvin. Greg Leisz, impegnato a maneggiare dobro e mandolino in soli due
o tre pezzi, mantiene una posizione assai più defilata rispetto a King Of California
e Blackjack David, e senza la sua direzione d'orchestra i musicisti, purtroppo,
non riescono a catturare il fascino, il mistero sottile e l'inquietudine guizzanti
tra le note dei traditionals affrontati. La registrazione "quadrata" e rockettara
di Mark Linnett, infine, non giova alla riuscita di un progetto afflitto dalla
rigidità questurina del sussidiario, e Public Domain se ne va a infoltire il novero
di quelle opere molto citate e, per carità, molto rispettate, che però quasi nessuno
ha mai voglia di ascoltare. O
di come certi dischi non andrebbero mai rispolverati, giacché vi sono occasioni
in cui il ricordo, pur deformato da altri fattori, è molto meglio della verifica.
Avevo un'opinione altissima di questo album, raccolta di vecchie canzoni folk
("spiriti che appartengono a ciascuno di noi", dice Alvin) tra l'altro contrassegnata
da un sorprendente successo anche al di fuori della nicchia del genere, finché
non l'ho ripreso in mano per la presente retrospettiva: con mia somma sorpresa,
mi sono trovato di fronte a 15 canzoni soporifere e sorpassate, a una galleria
di anticaglie folk dove, forse per la prima ed unica volta nel corso di un'intera
carriera, l'istintivo slancio di Dave Alvin nei confronti della tradizione
musicale del suo paese sembra rispondere non tanto a un desiderio di traduzione
creativa, bensì a una logica di conservazione museale e inutilmente ampollosa.
Il punto, qui, non è salvare questa o quell'altra interpretazione (il country-blues
di Maggie Campbell e Walk
Right In, il rockaccio furioso di Don't Let
Your Deal Go Down o l'evocativo passo folkie di Sign
Of Judgment passano l'esame senza alcun intoppo); il punto è che il
pur volenteroso ventaglio folk-rock aperto in Shenandoah
scompare in un batter d'occhio se paragonato, per dire, alla rilettura effettuata
da Bill Frisell nel quasi coevo Good Dog, Happy Man ('99) (tra parentesi molto
più affine al suono acustico dell'ultimo Alvin), e che la narcotica versione di
Texas Rangers qui contenuta la potremmo forse
accettare, fra uno sbadiglio e l'altro, in un disco didattico di Michael Martin
Murphey, o nelle fantasie di chi ancora gioca ai soldatini, non certo in un lavoro
di Dave Alvin. Greg Leisz, impegnato a maneggiare dobro e mandolino in soli due
o tre pezzi, mantiene una posizione assai più defilata rispetto a King Of California
e Blackjack David, e senza la sua direzione d'orchestra i musicisti, purtroppo,
non riescono a catturare il fascino, il mistero sottile e l'inquietudine guizzanti
tra le note dei traditionals affrontati. La registrazione "quadrata" e rockettara
di Mark Linnett, infine, non giova alla riuscita di un progetto afflitto dalla
rigidità questurina del sussidiario, e Public Domain se ne va a infoltire il novero
di quelle opere molto citate e, per carità, molto rispettate, che però quasi nessuno
ha mai voglia di ascoltare.
 Ashgrove [Yep Roc, 2004]
Ashgrove [Yep Roc, 2004]
Eleven Eleven [Yep Roc, 2011]
 Bringing
It All Back Home: Dave Alvin fa ritorno all'Ashgrove, il leggendario
club di Los Angeles dove scappava da giovane per vedere in azione i giganti del
blues e della musica soul, gli dedica il titolo dell'album e impacchetta ricordi
(la recente morte del padre) e nuove esperienze (da un contratto discografico
appena firmato a un tour dei Blasters che, fino all'annuncio delle date, nessuno
credeva possibile) in sei minuti di torrido rock-blues costruito su amplificatori
sfrigolanti e svisate di slide. Ashgrove, supportato dalla concisa
produzione del solito Leisz e dal drumming spettacolare di Don Heffington, è il
disco più compatto e fulminante (non necessariamente il più bello) di tutta la
carriera di Alvin, un'opera nata per sfogare la voglia di suonare roventi, sudati
e recalcitranti come i musicisti di un sordido juke-joint (la torrida Black
Sky sembra sbucare da una bettola di Clarksdale, Black
Haired Girl saetta blues chicagoano con strepitosa intensità urbana),
senza però dimenticare il gusto delle grandi ballate, della nostalgia per uno
struggente passato folkie per una volta svincolato dalla pretesa di suonare definitivo.
Tant'è che nel country-rock malinconico della bellissima Nine
Volt Heart, nella descrizione di una bambina triste che ricorre alla
radio per "volare lontano" quando si trova sola ("Aspettami in macchina, le disse
sua madre / mentre entrava in un bar a cercare papà"), abbiamo finalmente un degno
successore della storica Border Radio, e in Everett Ruess,
The Man In Bed e Somewhere
in Time altrettanti esempi di una felicità ineguagliabile nello sposare
rock e radici. Bringing
It All Back Home: Dave Alvin fa ritorno all'Ashgrove, il leggendario
club di Los Angeles dove scappava da giovane per vedere in azione i giganti del
blues e della musica soul, gli dedica il titolo dell'album e impacchetta ricordi
(la recente morte del padre) e nuove esperienze (da un contratto discografico
appena firmato a un tour dei Blasters che, fino all'annuncio delle date, nessuno
credeva possibile) in sei minuti di torrido rock-blues costruito su amplificatori
sfrigolanti e svisate di slide. Ashgrove, supportato dalla concisa
produzione del solito Leisz e dal drumming spettacolare di Don Heffington, è il
disco più compatto e fulminante (non necessariamente il più bello) di tutta la
carriera di Alvin, un'opera nata per sfogare la voglia di suonare roventi, sudati
e recalcitranti come i musicisti di un sordido juke-joint (la torrida Black
Sky sembra sbucare da una bettola di Clarksdale, Black
Haired Girl saetta blues chicagoano con strepitosa intensità urbana),
senza però dimenticare il gusto delle grandi ballate, della nostalgia per uno
struggente passato folkie per una volta svincolato dalla pretesa di suonare definitivo.
Tant'è che nel country-rock malinconico della bellissima Nine
Volt Heart, nella descrizione di una bambina triste che ricorre alla
radio per "volare lontano" quando si trova sola ("Aspettami in macchina, le disse
sua madre / mentre entrava in un bar a cercare papà"), abbiamo finalmente un degno
successore della storica Border Radio, e in Everett Ruess,
The Man In Bed e Somewhere
in Time altrettanti esempi di una felicità ineguagliabile nello sposare
rock e radici.
C'è parecchio blues elettrico anche nell'ultimo Eleven
Eleven, ancora una volta benedetto da un'inconfondibile capacità di sintesi
nel riunire tutte le anime della musica americana: il folk-rock di frontiera della
toccante No Worries Mija, gli esplosivi sortilegi
ritmici di una Run Conejo Run che strizza
l'occhio a Bo Diddley, il western-swing alcolico della rutilante Gary,
Indiana 1959, l'incalzare epico e percussivo di una Murietta's
Head ispirata all'omonimo Joaquin Carillo, "il Robin Hood dell'Eldorado",
un bandito leggendario (non si sa nemmeno se sia realmente esistito) che, durante
la "corsa all'oro" della California di metà '800, sottraeva i proventi delle miniere
per destinarli al popolo messicano (ma altre testimonianze sostengono li tenesse
per sé). La conclusiva Two Lucky Bums, sfuggente
parentesi jazz-lounge incisa con l'amico fraterno Chris Gaffney, sembra l'ennesima
constatazione di una vita piena e soddisfacente a dispetto dei numerosi lutti;
What's Up With Your Brother?, il pezzo dove
i fratelli Phil e Dave Alvin tornano finalmente a parlarsi (un piccolo evento,
in tutti i sensi), scherzando e cantando sulle proprie idisincrasie, sui propri
limiti e sulla constatazione di come, dopotutto, provare a rispettarsi sia meno
seccante che sentirsi ripetere in continuazione "cosa c'è che non va con tuo fratello?"
(benché sul finale, da veri istrioni, i due fingano di tornare a litigare… tutta
finzione?), ci ricorda invece di quanto sia importante, in quella stessa vita,
mantenere intatta la voglia di prendersi in giro e ridere, prima di tutto di se
stessi. "Non so nulla di numerologia, ma questo è il mio undicesimo album, contiene
undici canzoni ed esce nel 2011", scrive Alvin nelle note di copertina. E, be',
senza scomodare la teoria delle "anime radianti" e le sciocchezzaio sui messaggi
degli angeli (11:11 sarebbe una delle loro sequenze numeriche preferite…), non
possiamo che augurargli di continuare ad aumentare la cifra con gli stessi, splendidi
risultati.
 Interstate City [Hightone, 1996]
Interstate City [Hightone, 1996]
Out
In California [Shou! Factory, 2002]
Outtakes
In California [self-rel., 2002]
The
Great American Music Galaxy [Yep Roc, 2005]
Live
From Austin, Tx. - Austin City Limits [New West,
2007]
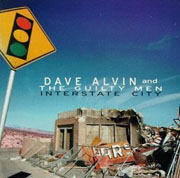 Sono
forse fin troppi i dischi dal vivo pubblicati da Dave Alvin dal 1996 ad
oggi, ma almeno il primo è consigliabile a tutti. Interstate City
è dinamite pura, uno dei live più tosti e trascinanti degli anni '90, che tra
country-rock da favola (So Long Baby Goodbye, Look Out (It Must Be Love),
Museum Of Heart, Waiting For The Hard Times To Go), rhytm'n'blues
ora fradicio di swing (Mister Lee) ora asciutto e cinematografico (Thirty
Dollar Room) ed esplosivi rock'n'roll à la Blasters (una ribollente Long
White Cadillac, il formidabile medley gospel-roots Jubilee Train / Do Re
Mi / Promised Land) potrebbe resuscitare un morto. I nove minuti e rotti di
un'incandescente Romeo's Escape in orbita rock boogie, con lo swing del
pianoforte e il fulmicotone delle chitarre a duellare senza sosta, sono l'apoteosi
dell'Alvin formato rocker, col cuore, il cervello e la sei corde piantati negli
anni '50 di Eddie Cochran, Fats Domino e Chuck Berry. Sei anni dopo, Out
In California (e il suo gemello Outtakes In California,
altre registrazioni live dello stesso tour vendute solo ai concerti o su internet)
sfodera ancora energia da vendere, ma in una dimensione di maggior cautela roots:
i brani più complessi e inclini alla lunga meditazione elettroacustica (su tutti
una magnifica Andersonville) risultano in
questa chiave ancor più efficaci, mentre le tirate rockiste e le rincorse rockabilly
(da Haley's Comet a Wanda And Duane, da American Music a
Fourth Of July) sembrano interpretate col freno a mano. Anche The
Great American Music Galaxy nasce in veste di curiosità da acquistare
durante le esibizioni live, ma la Yep Roc lo pubblica in via ufficiale dopo un
solo anno di diffusione "carbonara": scelta alquanto opportuna, visto che il disco,
molto più scuro, soulful e gospel del predecessore, assomiglia a un curioso quanto
riuscito tributo all'arte di Little Walter, di Elmore James e del primo Elvis,
con picchi stratosferici nel puro soul dell'acrobatica All
Night Worker, nella jam bluesy e fumigante di un'incontrollabile Ashgrove,
nel doo-wop rockato di una fantastica Trouble Bound, nel country-soul spumeggiante
di una East Texas Blues imbastardita con la Greenback Dollar di
Ray Harris, nel delirio terminale e rockinrollista di una Marie, Marie al
cardiopalma. Live From Austin, Tx., pur risalendo al 1999, vede
la luce nel 2007 e s'impone quale testimonianza più affidabile dei tour del periodo,
fotografati non benissimo da un Out In California un po' a corto di fiato e qualità
audio. La scaletta è più o meno quella solita degli show di allora, un diligente
percorso tra l'heartland-rock vicino a John Mellencamp di Fourth Of July
e Abilene e il country-blues sgranato delle varie Mary Brown, King
Of California e Blackjack David, fino alle detonazioni tutte schiaffi
boogie e unghiate r'n'r di Jubilee Train e Marie, Marie; la passione
è anche lei quella consueta, ed è in fondo il primo motivo per cui, ripetizioni
in scaletta o meno, di rinunciare a prodotti simili non ci passa neppure per l'anticamera
del cervello. Sono
forse fin troppi i dischi dal vivo pubblicati da Dave Alvin dal 1996 ad
oggi, ma almeno il primo è consigliabile a tutti. Interstate City
è dinamite pura, uno dei live più tosti e trascinanti degli anni '90, che tra
country-rock da favola (So Long Baby Goodbye, Look Out (It Must Be Love),
Museum Of Heart, Waiting For The Hard Times To Go), rhytm'n'blues
ora fradicio di swing (Mister Lee) ora asciutto e cinematografico (Thirty
Dollar Room) ed esplosivi rock'n'roll à la Blasters (una ribollente Long
White Cadillac, il formidabile medley gospel-roots Jubilee Train / Do Re
Mi / Promised Land) potrebbe resuscitare un morto. I nove minuti e rotti di
un'incandescente Romeo's Escape in orbita rock boogie, con lo swing del
pianoforte e il fulmicotone delle chitarre a duellare senza sosta, sono l'apoteosi
dell'Alvin formato rocker, col cuore, il cervello e la sei corde piantati negli
anni '50 di Eddie Cochran, Fats Domino e Chuck Berry. Sei anni dopo, Out
In California (e il suo gemello Outtakes In California,
altre registrazioni live dello stesso tour vendute solo ai concerti o su internet)
sfodera ancora energia da vendere, ma in una dimensione di maggior cautela roots:
i brani più complessi e inclini alla lunga meditazione elettroacustica (su tutti
una magnifica Andersonville) risultano in
questa chiave ancor più efficaci, mentre le tirate rockiste e le rincorse rockabilly
(da Haley's Comet a Wanda And Duane, da American Music a
Fourth Of July) sembrano interpretate col freno a mano. Anche The
Great American Music Galaxy nasce in veste di curiosità da acquistare
durante le esibizioni live, ma la Yep Roc lo pubblica in via ufficiale dopo un
solo anno di diffusione "carbonara": scelta alquanto opportuna, visto che il disco,
molto più scuro, soulful e gospel del predecessore, assomiglia a un curioso quanto
riuscito tributo all'arte di Little Walter, di Elmore James e del primo Elvis,
con picchi stratosferici nel puro soul dell'acrobatica All
Night Worker, nella jam bluesy e fumigante di un'incontrollabile Ashgrove,
nel doo-wop rockato di una fantastica Trouble Bound, nel country-soul spumeggiante
di una East Texas Blues imbastardita con la Greenback Dollar di
Ray Harris, nel delirio terminale e rockinrollista di una Marie, Marie al
cardiopalma. Live From Austin, Tx., pur risalendo al 1999, vede
la luce nel 2007 e s'impone quale testimonianza più affidabile dei tour del periodo,
fotografati non benissimo da un Out In California un po' a corto di fiato e qualità
audio. La scaletta è più o meno quella solita degli show di allora, un diligente
percorso tra l'heartland-rock vicino a John Mellencamp di Fourth Of July
e Abilene e il country-blues sgranato delle varie Mary Brown, King
Of California e Blackjack David, fino alle detonazioni tutte schiaffi
boogie e unghiate r'n'r di Jubilee Train e Marie, Marie; la passione
è anche lei quella consueta, ed è in fondo il primo motivo per cui, ripetizioni
in scaletta o meno, di rinunciare a prodotti simili non ci passa neppure per l'anticamera
del cervello.
| | |
|

 Secondo
pannello di un dittico con pochi eguali nella storia recente del rock delle radici,
Blackjack David fa ripartire la scrittura di Dave Alvin da altezze
vertiginose. Il team di musicisti è lo stesso di King Of California (in più c'è
Dillon O'Brian alle prese con fisarmonica e armonio), ma le canzoni, questa volta,
sono quasi tutta farina del sacco di Alvin, mai così sicuro, appuntito e preciso
nell'accumulare dettagli narrativi degni di un John Hiatt o di un Raymond Carver.
Dal border patrolman inorridito di fronte al ritrovamento di una clandestina già
cadavere (e comunque costretto a rimpatriarne il marito) in una California
Snow scritta a quattro mani con Tom Russell, fino al lento dissolversi
di una relazione descritto in Evening Blues
o al reduce ossessionato dal ricordo un commilitone abbandonato nella giungla
del Vietnam (1968, cointestata a Chris Gaffney), Blackjack David contiene alcune
delle migliori storie mai tratteggiate dall'autore, tutte confezionate in un suono
di elegantissima fattura elettroacustica. Anche lo schema della track-list, con
un sapiente intercalare di folk ambientale, scossoni roots e blues spettrali,
riprende quasi alla lettera quello del predecessore. Registrati nei Media Vortex
Studios di Burbank, California, tra il febbraio e il marzo del '98, il blues spagnoleggiante
della title-track, il mid-tempo roots-rock di Abilene,
la gracile tristezza folkie di From A Kitchen Table
(accompagnata con discrezione dal clarinetto e dall'organo di Doug Wieselman),
la solenne murder-ballad di Mary Brown o lo
swingato country & western di Laurel Lynn
(nelle parole di Alvin, "Howlin' Wolf incontra un fisarmonicista cajun e la band
di Roy Acuff") inquadrano il sobrio perimetro di stile di un disco tanto essenziale
quanto incisivo. La conclusione dell'album, affidata al rarefatto intreccio di
steel à la Daniel Lanois dell'evocativa Tall Trees,
apoteosi visionaria di dark-folk da qualche parte tra Blind Willie Johnson e Twin
Peaks, sintetizza in modo perfetto il suono al tempo stesso ruvido ed elegante
di un album i cui rintocchi assomigliano al lento schiudersi di una primavera
tardiva, foriera di un paesaggio dove i timidi raggi del primo sole ancora non
hanno disciolto il manto di neve appoggiato su case, strade e palazzi. "Ho sentito
dire che ti sei sposata / anche se avevi giurato che non l'avresti mai fatto /
Immagino tu abbia avuto dei bambini tuoi, ora, / gli racconti mai del vecchio
vicinato? / Come quella volta in cui rubammo la macchina di tuo padre / e guidammo
tutta la notte lungo la Imperial Highway / Tu continuavi a ripetere che dovevamo
tornare indietro, / io ti rispondevo che scappare non era poi così difficile",
canta Alvin nelle diminuite di From A Kitchen Table, e da quel tavolo, da questo
disco, si ha la sensazione di poter osservare un mondo.
Secondo
pannello di un dittico con pochi eguali nella storia recente del rock delle radici,
Blackjack David fa ripartire la scrittura di Dave Alvin da altezze
vertiginose. Il team di musicisti è lo stesso di King Of California (in più c'è
Dillon O'Brian alle prese con fisarmonica e armonio), ma le canzoni, questa volta,
sono quasi tutta farina del sacco di Alvin, mai così sicuro, appuntito e preciso
nell'accumulare dettagli narrativi degni di un John Hiatt o di un Raymond Carver.
Dal border patrolman inorridito di fronte al ritrovamento di una clandestina già
cadavere (e comunque costretto a rimpatriarne il marito) in una California
Snow scritta a quattro mani con Tom Russell, fino al lento dissolversi
di una relazione descritto in Evening Blues
o al reduce ossessionato dal ricordo un commilitone abbandonato nella giungla
del Vietnam (1968, cointestata a Chris Gaffney), Blackjack David contiene alcune
delle migliori storie mai tratteggiate dall'autore, tutte confezionate in un suono
di elegantissima fattura elettroacustica. Anche lo schema della track-list, con
un sapiente intercalare di folk ambientale, scossoni roots e blues spettrali,
riprende quasi alla lettera quello del predecessore. Registrati nei Media Vortex
Studios di Burbank, California, tra il febbraio e il marzo del '98, il blues spagnoleggiante
della title-track, il mid-tempo roots-rock di Abilene,
la gracile tristezza folkie di From A Kitchen Table
(accompagnata con discrezione dal clarinetto e dall'organo di Doug Wieselman),
la solenne murder-ballad di Mary Brown o lo
swingato country & western di Laurel Lynn
(nelle parole di Alvin, "Howlin' Wolf incontra un fisarmonicista cajun e la band
di Roy Acuff") inquadrano il sobrio perimetro di stile di un disco tanto essenziale
quanto incisivo. La conclusione dell'album, affidata al rarefatto intreccio di
steel à la Daniel Lanois dell'evocativa Tall Trees,
apoteosi visionaria di dark-folk da qualche parte tra Blind Willie Johnson e Twin
Peaks, sintetizza in modo perfetto il suono al tempo stesso ruvido ed elegante
di un album i cui rintocchi assomigliano al lento schiudersi di una primavera
tardiva, foriera di un paesaggio dove i timidi raggi del primo sole ancora non
hanno disciolto il manto di neve appoggiato su case, strade e palazzi. "Ho sentito
dire che ti sei sposata / anche se avevi giurato che non l'avresti mai fatto /
Immagino tu abbia avuto dei bambini tuoi, ora, / gli racconti mai del vecchio
vicinato? / Come quella volta in cui rubammo la macchina di tuo padre / e guidammo
tutta la notte lungo la Imperial Highway / Tu continuavi a ripetere che dovevamo
tornare indietro, / io ti rispondevo che scappare non era poi così difficile",
canta Alvin nelle diminuite di From A Kitchen Table, e da quel tavolo, da questo
disco, si ha la sensazione di poter osservare un mondo.  Il
fantasma dell'inverno di Blackjack David è scomparso. Al suo posto, ecco la mitezza
primaverile di una California bagnata dal sole, dall'abbraccio con l'asfalto,
dalle onde flessuose dell'oceano Pacifico, dall'ombra remota delle montagne del
vicino Oregon. West Of The West è il personale tributo dell'autore
alle canzoni di altri cantautori (dal Jackson Browne di Redneck
Friend al Tom Waits di Blind Love,
dai Los Lobos di Down On The Riverbed al Richard
Berry di I Am Bewildered), tutti accomunati
dal fatto di provenire dal cosiddetto "Sunshine State", e la conferma di come,
negli ultimi vent'anni, il Dave Alvin acustico (o semiacustico) abbia di
gran lunga superato, in fantasia e raffinatezza, la controparte elettrica. Naturalmente,
nemmeno qui latitano le eccezioni alla regola: il capolavoro del disco, una Loser
presa in prestito alle fantasticherie psych di Jerry Garcia e Robert Hunter (stava
sul debutto del barbuto chitarrista, l'omonimo Garcia del '72), trasforma il suono
dilatato e visionario dell'originale in un tagliente noir elettrico sferzato dalle
rasoiate di tre diverse chitarre, mentre il doo-wop celestiale della Surfer
Girl originaria (proprietà dei Beach Boys) regala l'occasione, grazie
alle armonie vocali dei Calvanes, per redigere un omaggio all'Elvis Presley formato
gospel delle registrazioni con i Jordanaires. Ma il succo dell'album resta nei
morbidi intrecci tra sei corde acustiche, organo, pianoforte e percussioni di
California Bloodlines (John Stewart) o Tramps
And Hawkers (Jim Ringer), due riletture che hanno il pregio di individuare
tutta la personalità dello stile di Alvin, imbattibile nel cesello di ballate
ingentilite dalle luci del tramonto, senza snaturare la lettera dei prototipi.
Incantevoli sono anche la malinconia western di una Kern
River (Merle Haggard) tutta pedal-steel, violino e mandolino, la nostalgica
tenerezza country-rock di una Here In California
(Kate Wolf) attraversata da slide e harmonies da manualistica del genere, il country-blues
per armonica, National Steel e pianoforte di Don't Look
Now (dai Creedence di Willy & The Poorboys). Giustissima, infine, l'inclusione
di Between The Cracks, brano scritto a quattro
mani da Dave Alvin e Tom Russell (la pubblicò per primo Alvin, su Museum Of Heart,
ma questa versione è più simile alla lettura russelliana reperibile nell'ottimo
The Rose Of The San Joaquin ['95]) su un pugile ("Kid Hey Zeus") sparito a Los
Angeles e sulla sua donna che continua ad aspettarlo, lavorando duro nei campi
della Valle di San Joaquin: un pezzo magnifico, colonna sonora ideale di un film
neanche tanto immaginario (Città Amara di John Huston andrebbe benissimo) ambientato
tra il Messico e la California, che dimostra, casomai ce ne fosse stato bisogno,
lo status di classico ormai raggiunto dal songwriting dell'artista.
Il
fantasma dell'inverno di Blackjack David è scomparso. Al suo posto, ecco la mitezza
primaverile di una California bagnata dal sole, dall'abbraccio con l'asfalto,
dalle onde flessuose dell'oceano Pacifico, dall'ombra remota delle montagne del
vicino Oregon. West Of The West è il personale tributo dell'autore
alle canzoni di altri cantautori (dal Jackson Browne di Redneck
Friend al Tom Waits di Blind Love,
dai Los Lobos di Down On The Riverbed al Richard
Berry di I Am Bewildered), tutti accomunati
dal fatto di provenire dal cosiddetto "Sunshine State", e la conferma di come,
negli ultimi vent'anni, il Dave Alvin acustico (o semiacustico) abbia di
gran lunga superato, in fantasia e raffinatezza, la controparte elettrica. Naturalmente,
nemmeno qui latitano le eccezioni alla regola: il capolavoro del disco, una Loser
presa in prestito alle fantasticherie psych di Jerry Garcia e Robert Hunter (stava
sul debutto del barbuto chitarrista, l'omonimo Garcia del '72), trasforma il suono
dilatato e visionario dell'originale in un tagliente noir elettrico sferzato dalle
rasoiate di tre diverse chitarre, mentre il doo-wop celestiale della Surfer
Girl originaria (proprietà dei Beach Boys) regala l'occasione, grazie
alle armonie vocali dei Calvanes, per redigere un omaggio all'Elvis Presley formato
gospel delle registrazioni con i Jordanaires. Ma il succo dell'album resta nei
morbidi intrecci tra sei corde acustiche, organo, pianoforte e percussioni di
California Bloodlines (John Stewart) o Tramps
And Hawkers (Jim Ringer), due riletture che hanno il pregio di individuare
tutta la personalità dello stile di Alvin, imbattibile nel cesello di ballate
ingentilite dalle luci del tramonto, senza snaturare la lettera dei prototipi.
Incantevoli sono anche la malinconia western di una Kern
River (Merle Haggard) tutta pedal-steel, violino e mandolino, la nostalgica
tenerezza country-rock di una Here In California
(Kate Wolf) attraversata da slide e harmonies da manualistica del genere, il country-blues
per armonica, National Steel e pianoforte di Don't Look
Now (dai Creedence di Willy & The Poorboys). Giustissima, infine, l'inclusione
di Between The Cracks, brano scritto a quattro
mani da Dave Alvin e Tom Russell (la pubblicò per primo Alvin, su Museum Of Heart,
ma questa versione è più simile alla lettura russelliana reperibile nell'ottimo
The Rose Of The San Joaquin ['95]) su un pugile ("Kid Hey Zeus") sparito a Los
Angeles e sulla sua donna che continua ad aspettarlo, lavorando duro nei campi
della Valle di San Joaquin: un pezzo magnifico, colonna sonora ideale di un film
neanche tanto immaginario (Città Amara di John Huston andrebbe benissimo) ambientato
tra il Messico e la California, che dimostra, casomai ce ne fosse stato bisogno,
lo status di classico ormai raggiunto dal songwriting dell'artista.  Quasi
nessuno ha colto la grazia enorme, la bellezza corale, la spontaneità di questo
album. Meglio così, forse: significa che in giro ci sono tanti ascoltatori con
una sorpresa che li attende dietro l'angolo. Dave Alvin & The Guilty Women,
progetto all-female canonizzato da Alvin dopo un'estemporanea esibizione del neonato
gruppo all'Hardly Strictly Bluegrass Festival di San Francisco in cui il nostro,
ipse dixit, si era limitato a radunare musiciste da sempre apprezzate, dimostra
in modo ancora una volta probante quante siano le possibilità di svecchiare una
tradizione, nonché un genere di solito appaltato alla metà maschile del cielo,
senza tradirne lo spirito ma, anzi, ringiovanendolo con pochi gesti schietti e
genuini. Non so se la freschezza del disco vada imputata a Christy McWilson (voce
solista), Cindy Cashdollar (chitarre steel, National, Weissenborn e resofoniche
assortite un fenomeno), Nina Gerber (sei corde), Laurie Lewis (mandolino), Amy
Farris (viola e violino), Sarah Brown (basso) e Lisa Pankratz (batteria), senza
dimenticare Marcia Ball (pianoforte) e Suzy Thompson (fisarmonica) in quanto donne;
so, tuttavia, che l'atmosfera sororale, di confidenza e intimità, diffusa lungo
tutte e dodici le canzoni dell'album non potrebbe prescindere dalla loro particolare
visione della materia roots, qui affrontata con una densità di sfumature e una
ricchezza di suoni spesso impossibile a reperirsi nei lavori di colleghi sovente
più interessati a manifestarne la forza virile ed epidermica (e, di riflesso,
poco attenti al fascino delle mezze tinte o al magnetismo delle allusioni). Ecco,
quindi, Marie, Marie nella sua versione più
bella di sempre, festosa e trascinante come un ballo cajun offerto alla luna svettante
sulla costa acadienne del Québec, ecco i velenosi suffumigi bluesy della crepitante
California's Burning, il folk-rock etereo
e malinconico di Downey Girl, l'hillbilly
appalachiano di una Weight Of The World che
sembra Dock Boggs travolto da Jerry Lee Lewis. Il commovente folk operistico di
Anyway, l'accorato country-gospel di Potter's
Field e la magnifica ballata rootsy These
Thimes We're Living In (un gioiello dimenticato di Kate Wolf) trovano
poi degni contraltari nel focoso rhytm'n'blues di Boss
Of The Blues (ennesimo peana di Alvin all'adorato Big Joe Turner),
nell'honky-tonk di Nana And Jimi e nel rock'n'roots
elettroacustico di River Under The Road e
Don't Make Promises (quest'ultima un vero
e proprio showcase di virtuosismi sugli strumenti a corda), fino alla chiosa deliziosa
di una Que Sera, Sera (proprio quella cantata
da Doris Day nell'hitchcockiano Uomo Che Sapeva Troppo ['56]), posta in coda all'album
per suggerire come tempo e speranze, in fondo, guariscano ogni ferita. Quasi ogni
ferita: Amy Farris, la piccola violinista rossocrinita che nel booklet
di Dave Alvin & The Guilty Women nasconde il proprio volto dietro il corpo dello
strumento, è stata ritrovata nella sua casa di L.A., priva di vita, pochi mesi
dopo la pubblicazione dell'album, vittima di un suicidio - questa la spietata
diagnosi delle autorità inquirenti - per intossicazione da antidepressivi.
Quasi
nessuno ha colto la grazia enorme, la bellezza corale, la spontaneità di questo
album. Meglio così, forse: significa che in giro ci sono tanti ascoltatori con
una sorpresa che li attende dietro l'angolo. Dave Alvin & The Guilty Women,
progetto all-female canonizzato da Alvin dopo un'estemporanea esibizione del neonato
gruppo all'Hardly Strictly Bluegrass Festival di San Francisco in cui il nostro,
ipse dixit, si era limitato a radunare musiciste da sempre apprezzate, dimostra
in modo ancora una volta probante quante siano le possibilità di svecchiare una
tradizione, nonché un genere di solito appaltato alla metà maschile del cielo,
senza tradirne lo spirito ma, anzi, ringiovanendolo con pochi gesti schietti e
genuini. Non so se la freschezza del disco vada imputata a Christy McWilson (voce
solista), Cindy Cashdollar (chitarre steel, National, Weissenborn e resofoniche
assortite un fenomeno), Nina Gerber (sei corde), Laurie Lewis (mandolino), Amy
Farris (viola e violino), Sarah Brown (basso) e Lisa Pankratz (batteria), senza
dimenticare Marcia Ball (pianoforte) e Suzy Thompson (fisarmonica) in quanto donne;
so, tuttavia, che l'atmosfera sororale, di confidenza e intimità, diffusa lungo
tutte e dodici le canzoni dell'album non potrebbe prescindere dalla loro particolare
visione della materia roots, qui affrontata con una densità di sfumature e una
ricchezza di suoni spesso impossibile a reperirsi nei lavori di colleghi sovente
più interessati a manifestarne la forza virile ed epidermica (e, di riflesso,
poco attenti al fascino delle mezze tinte o al magnetismo delle allusioni). Ecco,
quindi, Marie, Marie nella sua versione più
bella di sempre, festosa e trascinante come un ballo cajun offerto alla luna svettante
sulla costa acadienne del Québec, ecco i velenosi suffumigi bluesy della crepitante
California's Burning, il folk-rock etereo
e malinconico di Downey Girl, l'hillbilly
appalachiano di una Weight Of The World che
sembra Dock Boggs travolto da Jerry Lee Lewis. Il commovente folk operistico di
Anyway, l'accorato country-gospel di Potter's
Field e la magnifica ballata rootsy These
Thimes We're Living In (un gioiello dimenticato di Kate Wolf) trovano
poi degni contraltari nel focoso rhytm'n'blues di Boss
Of The Blues (ennesimo peana di Alvin all'adorato Big Joe Turner),
nell'honky-tonk di Nana And Jimi e nel rock'n'roots
elettroacustico di River Under The Road e
Don't Make Promises (quest'ultima un vero
e proprio showcase di virtuosismi sugli strumenti a corda), fino alla chiosa deliziosa
di una Que Sera, Sera (proprio quella cantata
da Doris Day nell'hitchcockiano Uomo Che Sapeva Troppo ['56]), posta in coda all'album
per suggerire come tempo e speranze, in fondo, guariscano ogni ferita. Quasi ogni
ferita: Amy Farris, la piccola violinista rossocrinita che nel booklet
di Dave Alvin & The Guilty Women nasconde il proprio volto dietro il corpo dello
strumento, è stata ritrovata nella sua casa di L.A., priva di vita, pochi mesi
dopo la pubblicazione dell'album, vittima di un suicidio - questa la spietata
diagnosi delle autorità inquirenti - per intossicazione da antidepressivi. Congedata
l'esperienza dei Blasters, Dave Alvin riappare nei negozi di dischi con
un ottimo lavoro solista che ha il solo difetto di non aggiungere quasi nulla
alle migliori intuizioni del vecchio gruppo (dal cui repertorio, peraltro, preleva
ben quattro canzoni). Romeo's Escape, aiutato dalla spigolosa produzione
stonesiana di Steve Berlin, suona dunque come un buon punto della situazione,
ma dal punto di vista della confezione non dice molto di più rispetto a quanto
già espresso, con ben altri colori e ben altra energia, tra i solchi di Hard Line,
l'indimenticabile canto del cigno della prima band del nostro. Il solitario disincanto
dell'asciutta Brother (On The Line) (forse
un'invocazione al fratello Phil), il "tiro" springsteeniano di I
Wish It Was Saturday Night e la grinta rootsy di Far
Away funzionano in modo impeccabile, eppure resta l'impressione di
trovarsi di fronte a un riassunto piuttosto che a un paradigma su cui scommettere
per il futuro. Il problema, evidenziato anche nel successivo Blue Blvd.,
sta in una band di secondo piano (complicazione del resto sofferta dal nostro
fino all'incontro con Greg Leisz) e in arrangiamenti che, pur volendo catturare
la magia di alcune grandi registrazioni del passato, finiscono per risultare un
po' vecchiotti e paludati. Il secondo album di Alvin, poi, nonostante diverse
tracce di ottima caratura (lo scuro folk-blues di Dry
River, il devastante rockabilly chitarristico di Haley's
Comet e Wanda And Duane, l'epico
populismo roots di Andersonville) risente
anche di un'invadente batteria fuori tempo massimo, per fortuna scomparsa, o meglio
ammorbidita, in Museum Of Heart, primo passo verso la definizione
del sound Americana dell'artista e tuttavia lavoro ancora incerto, zoppicante.
I suoi brani migliori (Thirty Dollar Room
e la title-track) verranno in seguito totalmente stravolti, il resto verrà dimenticato
piuttosto in fretta.
Congedata
l'esperienza dei Blasters, Dave Alvin riappare nei negozi di dischi con
un ottimo lavoro solista che ha il solo difetto di non aggiungere quasi nulla
alle migliori intuizioni del vecchio gruppo (dal cui repertorio, peraltro, preleva
ben quattro canzoni). Romeo's Escape, aiutato dalla spigolosa produzione
stonesiana di Steve Berlin, suona dunque come un buon punto della situazione,
ma dal punto di vista della confezione non dice molto di più rispetto a quanto
già espresso, con ben altri colori e ben altra energia, tra i solchi di Hard Line,
l'indimenticabile canto del cigno della prima band del nostro. Il solitario disincanto
dell'asciutta Brother (On The Line) (forse
un'invocazione al fratello Phil), il "tiro" springsteeniano di I
Wish It Was Saturday Night e la grinta rootsy di Far
Away funzionano in modo impeccabile, eppure resta l'impressione di
trovarsi di fronte a un riassunto piuttosto che a un paradigma su cui scommettere
per il futuro. Il problema, evidenziato anche nel successivo Blue Blvd.,
sta in una band di secondo piano (complicazione del resto sofferta dal nostro
fino all'incontro con Greg Leisz) e in arrangiamenti che, pur volendo catturare
la magia di alcune grandi registrazioni del passato, finiscono per risultare un
po' vecchiotti e paludati. Il secondo album di Alvin, poi, nonostante diverse
tracce di ottima caratura (lo scuro folk-blues di Dry
River, il devastante rockabilly chitarristico di Haley's
Comet e Wanda And Duane, l'epico
populismo roots di Andersonville) risente
anche di un'invadente batteria fuori tempo massimo, per fortuna scomparsa, o meglio
ammorbidita, in Museum Of Heart, primo passo verso la definizione
del sound Americana dell'artista e tuttavia lavoro ancora incerto, zoppicante.
I suoi brani migliori (Thirty Dollar Room
e la title-track) verranno in seguito totalmente stravolti, il resto verrà dimenticato
piuttosto in fretta.  O
di come certi dischi non andrebbero mai rispolverati, giacché vi sono occasioni
in cui il ricordo, pur deformato da altri fattori, è molto meglio della verifica.
Avevo un'opinione altissima di questo album, raccolta di vecchie canzoni folk
("spiriti che appartengono a ciascuno di noi", dice Alvin) tra l'altro contrassegnata
da un sorprendente successo anche al di fuori della nicchia del genere, finché
non l'ho ripreso in mano per la presente retrospettiva: con mia somma sorpresa,
mi sono trovato di fronte a 15 canzoni soporifere e sorpassate, a una galleria
di anticaglie folk dove, forse per la prima ed unica volta nel corso di un'intera
carriera, l'istintivo slancio di Dave Alvin nei confronti della tradizione
musicale del suo paese sembra rispondere non tanto a un desiderio di traduzione
creativa, bensì a una logica di conservazione museale e inutilmente ampollosa.
Il punto, qui, non è salvare questa o quell'altra interpretazione (il country-blues
di Maggie Campbell e Walk
Right In, il rockaccio furioso di Don't Let
Your Deal Go Down o l'evocativo passo folkie di Sign
Of Judgment passano l'esame senza alcun intoppo); il punto è che il
pur volenteroso ventaglio folk-rock aperto in Shenandoah
scompare in un batter d'occhio se paragonato, per dire, alla rilettura effettuata
da Bill Frisell nel quasi coevo Good Dog, Happy Man ('99) (tra parentesi molto
più affine al suono acustico dell'ultimo Alvin), e che la narcotica versione di
Texas Rangers qui contenuta la potremmo forse
accettare, fra uno sbadiglio e l'altro, in un disco didattico di Michael Martin
Murphey, o nelle fantasie di chi ancora gioca ai soldatini, non certo in un lavoro
di Dave Alvin. Greg Leisz, impegnato a maneggiare dobro e mandolino in soli due
o tre pezzi, mantiene una posizione assai più defilata rispetto a King Of California
e Blackjack David, e senza la sua direzione d'orchestra i musicisti, purtroppo,
non riescono a catturare il fascino, il mistero sottile e l'inquietudine guizzanti
tra le note dei traditionals affrontati. La registrazione "quadrata" e rockettara
di Mark Linnett, infine, non giova alla riuscita di un progetto afflitto dalla
rigidità questurina del sussidiario, e Public Domain se ne va a infoltire il novero
di quelle opere molto citate e, per carità, molto rispettate, che però quasi nessuno
ha mai voglia di ascoltare.
O
di come certi dischi non andrebbero mai rispolverati, giacché vi sono occasioni
in cui il ricordo, pur deformato da altri fattori, è molto meglio della verifica.
Avevo un'opinione altissima di questo album, raccolta di vecchie canzoni folk
("spiriti che appartengono a ciascuno di noi", dice Alvin) tra l'altro contrassegnata
da un sorprendente successo anche al di fuori della nicchia del genere, finché
non l'ho ripreso in mano per la presente retrospettiva: con mia somma sorpresa,
mi sono trovato di fronte a 15 canzoni soporifere e sorpassate, a una galleria
di anticaglie folk dove, forse per la prima ed unica volta nel corso di un'intera
carriera, l'istintivo slancio di Dave Alvin nei confronti della tradizione
musicale del suo paese sembra rispondere non tanto a un desiderio di traduzione
creativa, bensì a una logica di conservazione museale e inutilmente ampollosa.
Il punto, qui, non è salvare questa o quell'altra interpretazione (il country-blues
di Maggie Campbell e Walk
Right In, il rockaccio furioso di Don't Let
Your Deal Go Down o l'evocativo passo folkie di Sign
Of Judgment passano l'esame senza alcun intoppo); il punto è che il
pur volenteroso ventaglio folk-rock aperto in Shenandoah
scompare in un batter d'occhio se paragonato, per dire, alla rilettura effettuata
da Bill Frisell nel quasi coevo Good Dog, Happy Man ('99) (tra parentesi molto
più affine al suono acustico dell'ultimo Alvin), e che la narcotica versione di
Texas Rangers qui contenuta la potremmo forse
accettare, fra uno sbadiglio e l'altro, in un disco didattico di Michael Martin
Murphey, o nelle fantasie di chi ancora gioca ai soldatini, non certo in un lavoro
di Dave Alvin. Greg Leisz, impegnato a maneggiare dobro e mandolino in soli due
o tre pezzi, mantiene una posizione assai più defilata rispetto a King Of California
e Blackjack David, e senza la sua direzione d'orchestra i musicisti, purtroppo,
non riescono a catturare il fascino, il mistero sottile e l'inquietudine guizzanti
tra le note dei traditionals affrontati. La registrazione "quadrata" e rockettara
di Mark Linnett, infine, non giova alla riuscita di un progetto afflitto dalla
rigidità questurina del sussidiario, e Public Domain se ne va a infoltire il novero
di quelle opere molto citate e, per carità, molto rispettate, che però quasi nessuno
ha mai voglia di ascoltare.  Bringing
It All Back Home: Dave Alvin fa ritorno all'Ashgrove, il leggendario
club di Los Angeles dove scappava da giovane per vedere in azione i giganti del
blues e della musica soul, gli dedica il titolo dell'album e impacchetta ricordi
(la recente morte del padre) e nuove esperienze (da un contratto discografico
appena firmato a un tour dei Blasters che, fino all'annuncio delle date, nessuno
credeva possibile) in sei minuti di torrido rock-blues costruito su amplificatori
sfrigolanti e svisate di slide. Ashgrove, supportato dalla concisa
produzione del solito Leisz e dal drumming spettacolare di Don Heffington, è il
disco più compatto e fulminante (non necessariamente il più bello) di tutta la
carriera di Alvin, un'opera nata per sfogare la voglia di suonare roventi, sudati
e recalcitranti come i musicisti di un sordido juke-joint (la torrida Black
Sky sembra sbucare da una bettola di Clarksdale, Black
Haired Girl saetta blues chicagoano con strepitosa intensità urbana),
senza però dimenticare il gusto delle grandi ballate, della nostalgia per uno
struggente passato folkie per una volta svincolato dalla pretesa di suonare definitivo.
Tant'è che nel country-rock malinconico della bellissima Nine
Volt Heart, nella descrizione di una bambina triste che ricorre alla
radio per "volare lontano" quando si trova sola ("Aspettami in macchina, le disse
sua madre / mentre entrava in un bar a cercare papà"), abbiamo finalmente un degno
successore della storica Border Radio, e in Everett Ruess,
The Man In Bed e Somewhere
in Time altrettanti esempi di una felicità ineguagliabile nello sposare
rock e radici.
Bringing
It All Back Home: Dave Alvin fa ritorno all'Ashgrove, il leggendario
club di Los Angeles dove scappava da giovane per vedere in azione i giganti del
blues e della musica soul, gli dedica il titolo dell'album e impacchetta ricordi
(la recente morte del padre) e nuove esperienze (da un contratto discografico
appena firmato a un tour dei Blasters che, fino all'annuncio delle date, nessuno
credeva possibile) in sei minuti di torrido rock-blues costruito su amplificatori
sfrigolanti e svisate di slide. Ashgrove, supportato dalla concisa
produzione del solito Leisz e dal drumming spettacolare di Don Heffington, è il
disco più compatto e fulminante (non necessariamente il più bello) di tutta la
carriera di Alvin, un'opera nata per sfogare la voglia di suonare roventi, sudati
e recalcitranti come i musicisti di un sordido juke-joint (la torrida Black
Sky sembra sbucare da una bettola di Clarksdale, Black
Haired Girl saetta blues chicagoano con strepitosa intensità urbana),
senza però dimenticare il gusto delle grandi ballate, della nostalgia per uno
struggente passato folkie per una volta svincolato dalla pretesa di suonare definitivo.
Tant'è che nel country-rock malinconico della bellissima Nine
Volt Heart, nella descrizione di una bambina triste che ricorre alla
radio per "volare lontano" quando si trova sola ("Aspettami in macchina, le disse
sua madre / mentre entrava in un bar a cercare papà"), abbiamo finalmente un degno
successore della storica Border Radio, e in Everett Ruess,
The Man In Bed e Somewhere
in Time altrettanti esempi di una felicità ineguagliabile nello sposare
rock e radici. 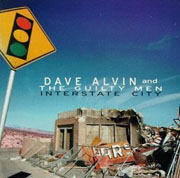 Sono
forse fin troppi i dischi dal vivo pubblicati da Dave Alvin dal 1996 ad
oggi, ma almeno il primo è consigliabile a tutti. Interstate City
è dinamite pura, uno dei live più tosti e trascinanti degli anni '90, che tra
country-rock da favola (So Long Baby Goodbye, Look Out (It Must Be Love),
Museum Of Heart, Waiting For The Hard Times To Go), rhytm'n'blues
ora fradicio di swing (Mister Lee) ora asciutto e cinematografico (Thirty
Dollar Room) ed esplosivi rock'n'roll à la Blasters (una ribollente Long
White Cadillac, il formidabile medley gospel-roots Jubilee Train / Do Re
Mi / Promised Land) potrebbe resuscitare un morto. I nove minuti e rotti di
un'incandescente Romeo's Escape in orbita rock boogie, con lo swing del
pianoforte e il fulmicotone delle chitarre a duellare senza sosta, sono l'apoteosi
dell'Alvin formato rocker, col cuore, il cervello e la sei corde piantati negli
anni '50 di Eddie Cochran, Fats Domino e Chuck Berry. Sei anni dopo, Out
In California (e il suo gemello Outtakes In California,
altre registrazioni live dello stesso tour vendute solo ai concerti o su internet)
sfodera ancora energia da vendere, ma in una dimensione di maggior cautela roots:
i brani più complessi e inclini alla lunga meditazione elettroacustica (su tutti
una magnifica Andersonville) risultano in
questa chiave ancor più efficaci, mentre le tirate rockiste e le rincorse rockabilly
(da Haley's Comet a Wanda And Duane, da American Music a
Fourth Of July) sembrano interpretate col freno a mano. Anche The
Great American Music Galaxy nasce in veste di curiosità da acquistare
durante le esibizioni live, ma la Yep Roc lo pubblica in via ufficiale dopo un
solo anno di diffusione "carbonara": scelta alquanto opportuna, visto che il disco,
molto più scuro, soulful e gospel del predecessore, assomiglia a un curioso quanto
riuscito tributo all'arte di Little Walter, di Elmore James e del primo Elvis,
con picchi stratosferici nel puro soul dell'acrobatica All
Night Worker, nella jam bluesy e fumigante di un'incontrollabile Ashgrove,
nel doo-wop rockato di una fantastica Trouble Bound, nel country-soul spumeggiante
di una East Texas Blues imbastardita con la Greenback Dollar di
Ray Harris, nel delirio terminale e rockinrollista di una Marie, Marie al
cardiopalma. Live From Austin, Tx., pur risalendo al 1999, vede
la luce nel 2007 e s'impone quale testimonianza più affidabile dei tour del periodo,
fotografati non benissimo da un Out In California un po' a corto di fiato e qualità
audio. La scaletta è più o meno quella solita degli show di allora, un diligente
percorso tra l'heartland-rock vicino a John Mellencamp di Fourth Of July
e Abilene e il country-blues sgranato delle varie Mary Brown, King
Of California e Blackjack David, fino alle detonazioni tutte schiaffi
boogie e unghiate r'n'r di Jubilee Train e Marie, Marie; la passione
è anche lei quella consueta, ed è in fondo il primo motivo per cui, ripetizioni
in scaletta o meno, di rinunciare a prodotti simili non ci passa neppure per l'anticamera
del cervello.
Sono
forse fin troppi i dischi dal vivo pubblicati da Dave Alvin dal 1996 ad
oggi, ma almeno il primo è consigliabile a tutti. Interstate City
è dinamite pura, uno dei live più tosti e trascinanti degli anni '90, che tra
country-rock da favola (So Long Baby Goodbye, Look Out (It Must Be Love),
Museum Of Heart, Waiting For The Hard Times To Go), rhytm'n'blues
ora fradicio di swing (Mister Lee) ora asciutto e cinematografico (Thirty
Dollar Room) ed esplosivi rock'n'roll à la Blasters (una ribollente Long
White Cadillac, il formidabile medley gospel-roots Jubilee Train / Do Re
Mi / Promised Land) potrebbe resuscitare un morto. I nove minuti e rotti di
un'incandescente Romeo's Escape in orbita rock boogie, con lo swing del
pianoforte e il fulmicotone delle chitarre a duellare senza sosta, sono l'apoteosi
dell'Alvin formato rocker, col cuore, il cervello e la sei corde piantati negli
anni '50 di Eddie Cochran, Fats Domino e Chuck Berry. Sei anni dopo, Out
In California (e il suo gemello Outtakes In California,
altre registrazioni live dello stesso tour vendute solo ai concerti o su internet)
sfodera ancora energia da vendere, ma in una dimensione di maggior cautela roots:
i brani più complessi e inclini alla lunga meditazione elettroacustica (su tutti
una magnifica Andersonville) risultano in
questa chiave ancor più efficaci, mentre le tirate rockiste e le rincorse rockabilly
(da Haley's Comet a Wanda And Duane, da American Music a
Fourth Of July) sembrano interpretate col freno a mano. Anche The
Great American Music Galaxy nasce in veste di curiosità da acquistare
durante le esibizioni live, ma la Yep Roc lo pubblica in via ufficiale dopo un
solo anno di diffusione "carbonara": scelta alquanto opportuna, visto che il disco,
molto più scuro, soulful e gospel del predecessore, assomiglia a un curioso quanto
riuscito tributo all'arte di Little Walter, di Elmore James e del primo Elvis,
con picchi stratosferici nel puro soul dell'acrobatica All
Night Worker, nella jam bluesy e fumigante di un'incontrollabile Ashgrove,
nel doo-wop rockato di una fantastica Trouble Bound, nel country-soul spumeggiante
di una East Texas Blues imbastardita con la Greenback Dollar di
Ray Harris, nel delirio terminale e rockinrollista di una Marie, Marie al
cardiopalma. Live From Austin, Tx., pur risalendo al 1999, vede
la luce nel 2007 e s'impone quale testimonianza più affidabile dei tour del periodo,
fotografati non benissimo da un Out In California un po' a corto di fiato e qualità
audio. La scaletta è più o meno quella solita degli show di allora, un diligente
percorso tra l'heartland-rock vicino a John Mellencamp di Fourth Of July
e Abilene e il country-blues sgranato delle varie Mary Brown, King
Of California e Blackjack David, fino alle detonazioni tutte schiaffi
boogie e unghiate r'n'r di Jubilee Train e Marie, Marie; la passione
è anche lei quella consueta, ed è in fondo il primo motivo per cui, ripetizioni
in scaletta o meno, di rinunciare a prodotti simili non ci passa neppure per l'anticamera
del cervello.