|
Stephen
Markley
Ohio
[Einaudi
pp.
544]

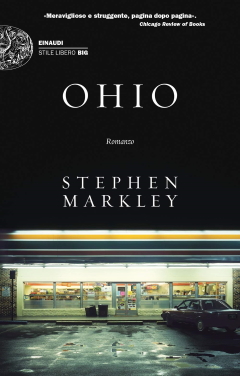 “Perdiamo
le persone Stacey. E non è mai giusto, non è mai accettabile, e c’è
sempre qualcosa che non torna” (Bill Ashcraft, Ohio) “Perdiamo
le persone Stacey. E non è mai giusto, non è mai accettabile, e c’è
sempre qualcosa che non torna” (Bill Ashcraft, Ohio)
La parata cittadina organizzata per i funerali di Rick Brinklan, uno
dei tanti ventenni tornati dall’Iraq dentro una bara, apre uno squarcio
sull’America dolente (e decadente) degli anni Duemila. Stephen Markley
disegna il toccante incipit di Ohio con uno stratagemma: ci inchioda
alla dimensione del dolore di un tempo sospeso tra le vite di gente
comune, in quella provincia altrettanto comune che dovrebbe evocare
il cuore della nazione, sempre pronta a chiamare i suoi figli al sacrificio.
La storia vera comincia dopo, ed è un ottovolante di ricordi, flashback,
andirivieni fra adolescenza e vita adulta che coinvolgerà tutti i protagonisti
di Ohio, un romanzo d’esordio potente, a volte azzardato,
con tutta la foga di un giovane scrittore ma anche graffi che da parecchio
non si leggevano su una pagina.
“In un’allucinogena notte estiva del 2013”, come sentenzia efficamente
Markley, “quattro automobili e i relativi occupanti convergono su
questa cittadina dell’Ohio”: dentro ci sono i corpi e le esistenze
lacerate - dai sensi di colpa, dai propri luoghi oscuri, oltre che da
dosi abbondanti di alcol e droga - di Bill Ashcraft, Stacey Moore, Dan
Eaton e Tina Ross, ex liceali, amici dello scomparso Rick Brinklan,
che hanno incrociato per un periodo i loro amori e le loro speranze
a New Canaan. Letteralmente si tratta di un buco d’America, con i suoi
Walmart, le sue tavole calde e bar, la stazione di polizia, la squadra
di football e ogni simbolico riferimento a un paese diviso e combattutto,
negli anni del terrorismo globale e della guerra infinita. Attorno ai
quattro, che capeggiano i macro-capitoli di Ohio intrecciando
avanti e indetro le loro storie come un gioco del destino (perché in
una piccola città, si sa, si finisce sempre per conoscersi e ritrovarsi
tutti quanti), ci sono altre vite, altri amici di gioventù, importanti
e rivelatori quanto e forse più di loro, a mano a mano che le pagine
crescono: la misteriosa e indipendente figura di Lisa Han, il violento
carattere di Todd Beaufort, la folle e pericolosa bellezza di Kaylyn
Lynn, il sensibile musicista Ben Harrington, e ancora madri e padri,
fratelli, insegnanti, volti che hanno scandito la crescita e poi l’abbandono
a New Canaan.
Markley li fa collidere spesso in maniera sconsiderata, tra il presente,
con i quattro principali attori che fanno il loro ingresso nel teatro
della cittadina durante la stessa notte, e i fantasmi del passato che
riemergono. Ohio diventa così l’implacabile scandire della perdita
dell’innocenza, come giustamente è stato descritto, quella dei protagonisti,
ormai trentenni e alla deriva, ma anche di New Canaan, dell’America
e degli americani. “L’amore può nascere a comando e la violenza può
essere aberrante, ma entrambi producono reazioni a catena”, sentenzia
Bill Ashcraft, ragazzo dilaniato dai mille sogni di rivolta politica
e sociale nei confronti di un paese che non ama e non capisce: ha ragione,
perché la vicenda che scorre sotterranea in Ohio e a forza di
strappi emerge come un fiume in piena è proprio una catena di eventi
quasi improbabili per coincidenze, e che pure sembrano alla lettura
inevitabili. Qui sta la forza di Markley e della sua scrittura, piena
zeppa di quella crudele ferocia che solo le memorie dell’adolescenza
di questi ragazzi può lasciare affiorare, con un bagaglio di espressioni,
sesso, e sentimenti.
Tutto è congegnato perché brandelli di verità, confessioni e gesti violenti
emergano dalla pagine fino al “termine della notte”, come Stephen Markley
intitola la chiusura del romanzo, allor quando i pezzi torneranno più
o meno al loro posto, come ci trovassimo nei risvolti di autentico noir
di provincia, ma niente affatto con l’idea moralistica di ristabilire
l’ordine: quest’ultimo era saltato fin dall’inizio in Ohio e
non sembra interessare il cuore della vicenda, che alterna senso di
compassione e condanna, buio e luce, innocenza, appunto, e totale abuso.
Come la vita.
(Fabio Cerbone)
Larry
Watson
Montana 1948
[Mattioli 1885 pp.
148]

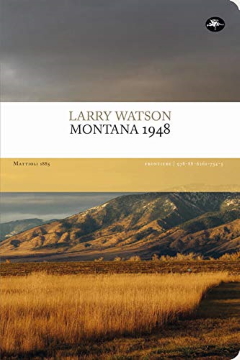 Stando
a un vecchio adagio riportato da Thomas McGuane in un dialogo di Solo
un cielo blu, “il Montana è stato costruito dalla ferrovia”. Call
e Augustus, i protagonisti di Lonesome Dove di Larry McMurtry,
potrebbero dissentire visto che lo vedevano come la terra promessa e,
per arrivarci con le loro mandrie, hanno dovuto combattere contro tutto
e tutti. In Canada, uno dei personaggi di Richard Ford diceva:
“Da queste parti ci sono solo vacche e grano”. Eppure c’è qualcosa in
quell’ambiente, con la polvere che riempie le strade e il vento pieno
di terra, che, nonostante gli spazi infiniti appare angusto, imprigionato
nelle dinamiche delle città di provincia, ben rappresentate dalla personalità
della famiglia Hayden. Stando
a un vecchio adagio riportato da Thomas McGuane in un dialogo di Solo
un cielo blu, “il Montana è stato costruito dalla ferrovia”. Call
e Augustus, i protagonisti di Lonesome Dove di Larry McMurtry,
potrebbero dissentire visto che lo vedevano come la terra promessa e,
per arrivarci con le loro mandrie, hanno dovuto combattere contro tutto
e tutti. In Canada, uno dei personaggi di Richard Ford diceva:
“Da queste parti ci sono solo vacche e grano”. Eppure c’è qualcosa in
quell’ambiente, con la polvere che riempie le strade e il vento pieno
di terra, che, nonostante gli spazi infiniti appare angusto, imprigionato
nelle dinamiche delle città di provincia, ben rappresentate dalla personalità
della famiglia Hayden.
Anche David, il giovane protagonista di Montana 1948,
nonché voce narrante, sente sulla pelle “un certo rispetto che non
avevo avuto bisogno di guadagnarmi”, mentre cammina per Bentrock.
È l’unico rappresentante dell’ultima generazione degli Hayden, nei tratti
caratteriali ben disegnati da Larry Watson: il capostipite, Julian,
nonno di David, e padre di Wesley e Frank, è un uomo della frontiera
“ricco e potente”, che ha inaugurato la saga degli sceriffi Hayden nella
contea di Mercer. Frank, il figlio maggiore, è tornato dalla guerra
come un eroe, è sposato con Gloria ed è un medico. È più brillante e
divertente, anche se dal suo matrimonio non sono ancora arrivati figli.
Il contrasto tra i fratelli anticipa lo scontro vero e proprio. Wesley
procede per inerzia e più che uno sceriffo, ruolo che ha ricevuto per
investitura dal padre, pare un travet della prateria. Anche la pistola
d’ordinanza (piccola e italiana!), che definisce uno status, è lontana
anni luce dallo standard abituale del West e dell’America in generale
dove, si sa, il culto delle armi è sancito dalla costituzione.
In tutto Montana 1948 viene sparato un singolo colpo di fucile,
ma il suo eco rimbomba nelle valli e a quel punto le dinamiche famigliari,
viste con gli occhi di David, sono già collassate. Lui adora tutti,
ma è innamorato della governante sioux, Marie Piccolo Soldato. Quando
Marie si ammala di polmonite, è spontaneo chiamare Frank al suo capezzale,
ma la reazione della donna sorprende tutti. Non vuole essere sfiorata
dal dottore. Da lì emerge una sordida storia di abusi sessuali del fratello
maggiore degli Hayden nei confronti delle donne indiane. David, attonito,
si chiede: “Quanti altri segreti la nostra città aveva accettato
di mantenere?”. Il dilemma, molto shakespeariano, deflagra in multiple
contrapposizioni (fratello contro fratello, figlio versus padre, cowboy
e indiani, uomini e donne) nello scenario della casa di Wesley che arresta
Frank ma, per precauzione, invece di condurlo nelle celle del tribunale,
dall’altra parte della strada, lo chiude nel seminterrato. David assiste,
impotente e titubante, all’evolversi del conflitto tra le mura casalinghe:
“Non ero sicuro di cosa fosse diventata la nostra famiglia in quei
giorni difficili, ma sapevo che dovevamo stare vicini. Eravamo sotto
assedio. Dovevamo sostenere meglio che potevamo le pareti della nostra
casa”. È grazie al suo punto di vista che Larry Watson può raccontare
gli sviluppi che travolgono la famiglia Hayden. È un modo brillante
per vedere la storia di Montana 1948 da più angolazioni perché,
come annota David, quel momento “segnò una tale frattura nella nostra
vita, un abisso che divise definitivamente ciò che eravamo, e che non
saremmo più potuti essere, da ciò che saremmo diventati, che bisognerebbe
trovare un’unità di misura più adeguata”. Da lì il destino degli
Hayden è sconvolto per sempre. Le peculiari caratteristiche morfologiche
del Montana hanno un peso determinante, anche se Larry Watson pone al
centro dell’attenzione le vicende umane.
L’equilibrio di Montana 1948 sta esattamente tra i silenzi della
wilderness e le chiacchiere cittadine, tra gli echi delle montagne e
il rumore dei pensieri. La scrittura si insinua proprio in quella dimensione,
rilevando con eleganza e senso della misura l’attrito tra le pause implicite
alla vastità del territorio del Montana con gli scatti imprevedibili
degli esseri umani che lo abitano. Un piccolo classico, una riscoperta
obbligatoria.
(Marco Denti)
Willy
Vlautin
Motel Life
[Jimenez
pp.
202
]

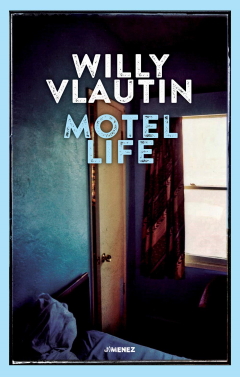 In
prospettiva, nel suo esordio Willy Vlautin esplorava già temi
che sarebbero emersi in primo piano nei romanzi successivi: la boxe
(in Io sarò qualcuno), i cavalli (in La ballata di Charley
Thompson) come se nella Motel Life ci fossero tutti
gli elementi fondamentali della sua scrittura. Soprattutto c’era una
direzione precisa, nell’avvicinarsi al buio di esistenze aride e smarrite,
dove “le cose vanno e vengono come le onde”, ma le persone sono abbandonate
come relitti sulla spiaggia. I maggiori rappresentanti di un territorio,
quello della Motel Life di Willy Vlautin, in cui tutto è rovinato,
arrugginito, scartato e di seconda mano, dalla automobili alle suppellettili,
sono i fratelli Flannigan. Jerry Lee ha investito un ragazzo ed è in
preda al panico, Frank lo asseconda come ha sempre fatto, perché si
compensano a vicenda, ma sono comunque da tempo alla deriva. Vagano
per Reno, ricordando il passato, cercando una soluzione che non c’è.
Sono impacciati, affamati, disorientati da una costante nebbia alcolica,
e nel gelo dell’inverno, il motel diventa una casa istantanea, un riparo
provvisorio, e transitorio proprio come ogni altra cosa. In
prospettiva, nel suo esordio Willy Vlautin esplorava già temi
che sarebbero emersi in primo piano nei romanzi successivi: la boxe
(in Io sarò qualcuno), i cavalli (in La ballata di Charley
Thompson) come se nella Motel Life ci fossero tutti
gli elementi fondamentali della sua scrittura. Soprattutto c’era una
direzione precisa, nell’avvicinarsi al buio di esistenze aride e smarrite,
dove “le cose vanno e vengono come le onde”, ma le persone sono abbandonate
come relitti sulla spiaggia. I maggiori rappresentanti di un territorio,
quello della Motel Life di Willy Vlautin, in cui tutto è rovinato,
arrugginito, scartato e di seconda mano, dalla automobili alle suppellettili,
sono i fratelli Flannigan. Jerry Lee ha investito un ragazzo ed è in
preda al panico, Frank lo asseconda come ha sempre fatto, perché si
compensano a vicenda, ma sono comunque da tempo alla deriva. Vagano
per Reno, ricordando il passato, cercando una soluzione che non c’è.
Sono impacciati, affamati, disorientati da una costante nebbia alcolica,
e nel gelo dell’inverno, il motel diventa una casa istantanea, un riparo
provvisorio, e transitorio proprio come ogni altra cosa.
La strada resta l’unica opportunità per fuggire perché Frank e Jerry
Lee non fanno molto oltre a guardare la televisione (una noia assoluta),
arrancare nella neve e bere birra (i pacchi da sei arrivano fino a dodici
nel corso del romanzo). L’unico momento di fragile felicità che ricordano
è quando “avevamo intorno la città, la gente e il traffico, le luci
dei casinò e il rumore, ma era come se per noi andasse tutto bene, come
se tutto fosse perfetto, come se fossimo le uniche due persone al mondo
che avessero importanza, le uniche che potevano vedere quanto erano
belle le luci della città”. Trascinandosi senza alcuna idea, finisce
che Jerry Lee, travolto dal rimorso, tenta il suicidio, e gli viene
male anche quello, visto che finisce per spararsi in una gamba. Ma Frank
è sempre presente, pronto a celebrare un legame indissolubile raccontando
al fratello le storie che si inventa per sopravvivere. Iris, uno dei
suoi personaggi, spiega bene il senso di resistere alle spinte che ci
vogliono “senza differenze, senza desideri, con tutto il peso del
mondo sulle spalle, che ci schiaccia e ci rende tutti uguali”. Solo
che per Iris contano soltanto “le quattro parole fondamentali della
vita: buona conoscenza delle pistole”, un motto che annuncia l’inevitabile
destino della sua storia.
D’altra parte in tutta la Motel Life l’unica persona “serena e in
pace con se stessa” si chiama Marge, ed è soltanto un disegno, frutto
dell’estro di Jerry Lee, appeso sulla parete dell’ennesimo motel. La
speranza è meglio di niente, d’accordo, ma vivere come i fratelli Flannigan
condensa una condizione umana faticosa oltre che dolorosa. Non bastasse,
Tommy, perché ci sono perdenti capaci di scommettere sulle sconfitte
degli altri, spinge Frank a puntare i suoi ultimi soldi. Del resto siamo
a Reno, e il gioco d’azzardo è un altro dei temi ricorrenti, visto che
risale anche al padre dei Finnigan, ma è una sfida con la vita. “Anche
i perdenti sono fortunati a volte” cantava Tom Petty in Even The
Losers e infatti Frank riesce a piazzare una bella vincita sullo
scontro Tyson versus Holyfield e con il bottino si compra una macchina
(americana, pur sapendo che quelle giapponesi sono più affidabili: un’altra
scelta frutto dell’attitudine da loser) per partire ancora una volta.
Oltre a lasciarsi alle spalle Reno, Frank intende ritrovare Annie James,
che aveva lasciato, anni prima, colta anche lei in una situazione oltre
ai limiti della decenza.
La galleria di disperati è affollata e mutevole, ma i personaggi sono
vividi (compreso un cane che entra a far parte della compagnia), le
immagini colpiscono, il tono della scrittura è perfetto perché
Motel Life come scrive Willy Vlautin nella postfazione è
“un romanzo sulla nostalgia di casa”, ovvero “un sogno a occhi
aperti, un sogno triste”, con la colonna sonora di Willie Nelson
e Johnny Cash, gente che è sempre stata dalla parte delle vittime.
(Marco Denti)
Jesmyn
Ward
La linea del sangue
[NNEditore
pp.
380]

 Nel
giorno del diploma, i gemelli Joshua e Christophe si lanciano nel fiume.
Finita la scuola, gli si spalanca un mondo davanti. Ma vivono a Bois
Sauvage, la contea che da qui sarà lo sfondo anche di Salvare le
ossa e Canta, spirito, canta. Per seguire La linea
del sangue bisogna sprofondare nel bayou, che è un ecosistema
tra acqua dolce e salata, tra terra e mare che si mischiano grazie a
vento e correnti e nel caso specifico di Bois Sauvage anche tra Mississippi
e Louisiana, dove “piccole comunità autonome” si sono insediate in altrettante
enclavi. Nel
giorno del diploma, i gemelli Joshua e Christophe si lanciano nel fiume.
Finita la scuola, gli si spalanca un mondo davanti. Ma vivono a Bois
Sauvage, la contea che da qui sarà lo sfondo anche di Salvare le
ossa e Canta, spirito, canta. Per seguire La linea
del sangue bisogna sprofondare nel bayou, che è un ecosistema
tra acqua dolce e salata, tra terra e mare che si mischiano grazie a
vento e correnti e nel caso specifico di Bois Sauvage anche tra Mississippi
e Louisiana, dove “piccole comunità autonome” si sono insediate in altrettante
enclavi.
Il terreno, a cui Jesmyn Ward si dedica in modo ossessivo, è
tutto: le strade sono ricoperte di gusci d’ostrica, il fango è onnipresente,
la vegetazione nasconde insidie a ogni passo e il clima è ostico. L’afa
è insopportabile e il caldo, che non concede tregua, brucia sulla pelle,
rallenta i movimenti, alimenta la noia. La convivenza con l’ambiente
complica i rapporti, anche se la famiglia, che resta sempre incompleta,
è ancora un punto di riferimento inamovibile. Se in qualche modo resta
funzionale, lo deve ai rami femminili: Joshua e Christophe sono stati
cresciuti da Ma-mee, che è la nonna. È quasi cieca, un dettaglio non
relativo, perché gli occhi spesso ingannano e lei, in fondo, riesce
a vedere meglio di tutti gli altri. E sente la tempesta in arrivo perché
a Bois Sauvage il futuro è un elenco di posti in cui fare domanda di
lavoro, una specie di penitenza verso occupazioni dure, ripetitive,
se non umilianti. Joshua è il primo a trovare un impiego, come scaricatore
di porto. Un mestiere faticoso e senza sbocchi, ma onesto. Christophe
invece segue la scia del cugino Dunny e comincia a spacciare. All’inizio
è solo erba, poi cominciano a vedersi anche coca e crack.
Come si conviene, è lì che La linea del sangue si spezza: a ridosso
del quattro luglio, con le tavole imbandite e i fuochi artificiali nel
cielo, l’armonia tra i due fratelli s’infrange negli scorci di vita
che hanno intravisto. Joshua ha trovato un suo posto e una ragazza,
Laila. Christophe scompare per intere giornate, per poi riapparire con
le tasche piene di rotoli di dollari. Ma-mee sente che qualcosa non
va, anche perché, prima o poi, tutti tornano a Bois Sauvage: arriva
Cille, la madre dei gemelli, e ricompare Sandman alias Samuel, il padre,
che ormai è un tossico senza speranza. Il quadro famigliare è completo
come uno specchio infranto che si regge soltanto per la cornice: tra
loro mancano le parole, il tempo, la consuetudine. Jesmyn Ward interpreta
con scrupolosa lentezza ogni movimento, la percezione dei corpi, i gesti
quotidiani che nascondono e insieme rivelano i turbamenti, le incomprensioni
e le inquietudini dei protagonisti. Ma-mee, che è un po’ il deus ex
machina di Bois Sauvage, nei momenti più imbarazzanti e difficili riordina
e cucina, quasi seguendo un riflesso condizionato, perché il cibo (e
seguendo con attenzione La linea del sangue si scopre un dettagliato
menù della saporita gastronomia del bayou) è l’unico momento di condivisione.
Le fratture tra Joshua e Christophe, fra i gemelli, Cille e Sandman,
l’intrufolarsi nell’ambiguità, dove domina la paranoia e basta una macchina
della polizia o il volto di uno sconosciuto a scatenare il panico, portano
evidentemente a condizioni dove il sangue, alla fine, non sarà solo
metaforico. L’ipnotico racconto di Jesmyn Ward, con l’apparizione dei
personaggi che da lì si faranno largo nella trilogia di Bois Sauvage,
è insieme aspro, torbido e sensuale, ma sta parlando di una realtà che
deve pagare le cure ospedaliere a rate, perché i confini del bayou sono
indefiniti, ma sono comunque nell’America disastrata del ventunesimo
secolo. Ed è così che La linea del sangue comincia e finisce
in riva al fiume, dove il suo senso spicciolo è palese: all’inizio la
vita è un tuffo a occhi chiusi, poi peschi un po’ quello che trovi.
Resta da dire dell’affollata colonna sonora con cui Jesmyn Ward punteggia
La linea del sangue: Harold Melvin and the Blue Notes, Clarence Carter,
Otis Redding, Al Green, Bobby Blue Band, gli Earth, Wind & Fire e Sam
Cooke. È un’ottima selezione di soul e rhythm and blues ma La linea
del sangue ha più la cadenza tambureggiante e insistente di una canzone
dei Neville Brothers, la famiglia musicale più nota a New Orleans. Il
titolo è Sons And Daughters e l’album da cui è tratta, guarda caso,
si chiama Brother’s Keeper e (sentire per credere) sembra uscire
direttamente dalla radio di Ma-mee.
(Marco Denti)
|