
| Claudia
Buonadonna
Patti Smith
[Arcana]
pp. 383  Acquista
Acquista
|

E' uno strano equilibrio quello su cui si regge la poetica di Patti Smith.
Da una parte c'è una proiezione profetica, capace di vedere attraverso e per il
mondo che la fa sentire "un'artista americana senza colpe" capace di sentire il
proprio e il nostro tempo come nessun altro: "Stiamo vivendo tempi difficili,
ma appunto per questo abbiamo il diritto e il dovere di prendere le strade e le
piazze e far sapere che non ce ne staremo qui a guardarli rovinare il nostro mondo!".
L'invocazione, riportata nell'introduzione a "tutti i testi commentati" con garbo
e senso della misura da Claudia Buonadonna, celebra la Patti Smith più
battagliera, quella che da People Have The Power a Radio Baghdad offre infinite
occasioni per comprendere cosa vuol dire essere un'artista tra due secoli feroci.
E' il suo lato di pubblico dominio, quello che emerge di più, non l'unico: infatti,
affrontando le canzoni una per una, con il gusto per le storie e senza la mania
dell'esegesi a tutti i costi, Claudia Buonadonna mette in evidenza e racconta
anche gli aspetti più lirici legati agli amatissimi simbolisti francesi, così
come alle visioni di Jim Morrison e di tutti gli altri suoi "eroi" o quei temi
legati alla sua autobiografia e alla sua famiglia (basta pensare a Kimberly).
L'opera omnia rappresenta un'artista che, come conclude Claudia Buonadonna, ha
indicato "una libertà da perseguire con fervore estremo". Se serve (eccome, se
serve) ricordarlo, questa è l'occasione giusta. | |  |
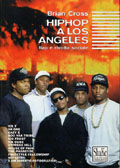 |
Brian
Cross
Hip Hop a Los Angeles
[Shake]
pp. 254  Acquista
Acquista
|
| 
Premesso che sul tema esiste un libro esaustivo come quello di Simon Reynolds,
Hip Hop Rock 1985-2008 (ISBN), la ristampa di Hiphop a Los Angeles,
un titolo che risale al 1993, merita senza dubbio qualcosa in più di una menzione
d'onore. Intanto quello di Brian Cross è stato uno dei primi tentativi
di comprendere il linguaggio, non soltanto ritmico e musicale, usato dai "vietcong
della nostra società" come venivano chiamati in un'infelice battuta le gang nere
di Los Angeles, in particolare i Blood e i Crip. Un lavoro svolto rimanendo sulla
frontiera dell'hiphop, la strada, la "città di quarzo" di Mike Davis, che Brian
Cross ha cercato di definire partendo dalle radici afroamericane, dal blues e
dal jazz. Una delle voci più autorevoli citate nelle prime pagine di Hiphop a
Los Angeles è quella di Max Roach che offre un punto di vista singolare e molto
interessante: "La cosa dell'hiphop che ha spaventato maggiormente è stato sentire
che la gente si godeva il ritmo in sé e per sé. L'hiphop vive nel mondo, non nel
mondo della musica, ecco perché è così rivoluzionario". Il metodo scelto da Brian
Cross è a sua volta legato in modo naturale all'hiphop perché, per capire come
da voce dei ghetti vessati e combattuti sia diventato una forma culturale conosciuta
worlwide, ha allineato una serie di interviste che raccontano la vera storia in
prima persona. Come quella di Eazy E che sognava "una grossa etichetta, grande
come la Motown, tutta mia". Morirà di Aids nel 1995. O come quella di Dr Dre che
finiva la sua intervista dicendo: "Puoi dire quel cazzo che vuoi, non c'è modo
di rovinarmi la reputazione, sono già un bad boy". Un'ottima riscoperta..
|
|
 |
Adrian
Johns
Pirateria
[Bollati
Boringhieri]
pp. 717
|
| 
Per qualcuno la pirateria sarà la catastrofe del ventunesimo secolo e chi si scarica
qualche canzone (anche qualche migliaio di canzoni) è collocabile nelle liste
dei nemici pubblici, magari non proprio al primo posto, ma in buona compagnia
tra terroristi e serial killer. Per qualcun altro la pirateria è poco più di un
hobby con cui trastullarsi, poco importa poi se in una frazione di secondo vi
possono sfilare la vostra identità senza battere ciglio. Leggendo Pirateria
si capisce che la verità non sta nemmeno nel mezzo perché la monumentale "storia
della proprietà intellettuale da Gutember a Google" di Adrian Johns (circa
settecento pagine belle dense) non ospita banali luoghi comuni e dimostra che
la pirateria nasce e cresce parallela alla proprietà intellettuale. E non è una
scoperta di ieri, per dirla proprio con Adrian Johns: "La pirateria non è propria
della rivoluzione digitale, una rivoluzione tra l'altro indissociabile dal suo
retaggio storico. Né è un semplice accessorio nello sviluppo della dottrina giuridica.
Ma non è neanche un reato senza tempo, definibile in modo universale e secondo
criteri assoluti. E' qualcosa di ben più ricco e sfuggente". Quello che mostra
Adrian Johns, e che dovrebbe far riflettere, è che se la pirateria ha lo status
che ha lo si deve solo al mercato, e non certo a qualche bizzarra idea pseudorivoluzionaria.
E' naturale che la tesi, qui dimostrata con ampi margini di ragionevolezza, dia
fastidio, ma andare contro la storia è, se non altro, imbarazzante. Fondamentale.
| |  |
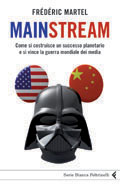 |
Frédéric
Martel
Mainstream
[Feltrinelli]
pp. 440
 Acquista
Acquista
|
| 
Tutti noi scriviamo, leggiamo e più in generale usiamo e condividiamo la parola
mainstream, anche se con il tempo il suo significato è andato deformandosi. Seguendo
la sua evoluzione Frédéric Martel ha scritto un imponente storia dell'entertainment,
seguendone con scrupolo il profilo di volta in volta politico, economico e sociale.
Uno sforzo notevole visto che ha saputo coniugare un'incredibile ricchezza di
informazioni con un tono narrativo, destinato a far comprendere con chiarezza
le fondamenta del mainstream. Partiamo dalla definizione iniziale: mainstream
è una "parola di origine americana che può voler dire grande pubblico, dominante,
popolare. L'espressione cultura mainstream può avere una connotazione positiva,
nel senso di cultura per tutti, ma anche negativa, nel senso di cultura egemonica".
Il fatto che il mainstream abbia radici americane non dovrebbe sorprenderci: da
Hollywood a Nashville sappiamo bene quanto contano e quantono pesano le logiche
mainstream (basta pensare alle playlist radiofoniche) nel determinare il gusto
e il successo, se non altro perché ci occupiamo di tutto quanto è americano, ma
nella direzione opposta e contraria. Guarda caso, Luke Lewis, presidente della
Universal a Nashville, proprio nelle pagine di Mainstream non riesce a spiegarsi
perché il "loro" country & western" non riesca a imporsi in tutto il mondo. Senza
scomodare il cosiddetto "lo scontro di civiltà" da cui il pur eccellente Mainstream
comincia, potremmo benissimo rispondergli noi.
| |