|
"Se David Lynch dovesse mettere insieme una band dal nulla, ci sarebbero buone
probabilità che se ne esca fuori con qualcosa di molto simile ai Thin White Rope"
(Trouser Press)
Quale è il suono
prodotto dal deserto? Chiedetelo ai Thin White Rope, anche
se il mistero non verrà risolto. Desert rock, sigla quanto mai
imperscrutabile, fra le definizioni più stranianti che la critica
potesse inventare, eppure appiccicata addosso al corpo di questa
band come un marchio che ne sveli la natura ancestrale della sua
musica, il senso di mistero e bellezza, il contrasto stridente
fra terra e cielo, luce ed oscurità che ha percorso l'intera produzione
discografica. Il Mojave, la Death Valley, le palme di Yucca che
si stagliano nel parco nazionale di Joshua tree si allargano lontane
nel panorama, a sud ovest rispetto alla cittadina universitaria
di Davis, California, sobborghi di Sacramento. È qui che prende
forma una delle avventure più ignorate e di culto dell'underground
rock americano degli anni Ottanta, nel bel mezzo di quel fermento
post punk della costa ovest che avrebbe generato il chiacchiericcio
intorno al fantomatico movimento denominato "Paisley Undergournd".
Fin dal principio la storia dei Thin White Rope - "sottile corda
bianca", eufemismo per indicare il liquido seminale utilizzato
dallo scrittore Willam Burroughs nel famoso capolavoro di "cut-up
and fold-in" Il pasto Nudo - si sviluppa come una anomalia,
una contorta, incatalogabile roccia di grezzo rock dalle movenze
western che soltanto di striscio, per generali affinità elettive,
può essere affiancato alla contemporanea e vivace sommossa neo-psichedelica
che sta coinvolegendo fra gli altri Dream Syndicate (Steve Wynn
forma il primo nucleo della band con Kendra Smith proprio nel
campus universitario di Davis), True West e Green on Red.
Guy Kyser, Roger Kunkel e Josepf Becker frequentano l'ambiente
agli albori del decennio: c'è un orizzonte nuovo che sta sorgendo
dalle ceneri della ribellione hardcore punk, la California riscopre
con diverso livore il suo passato, le fondamenta non solo della
psichedelia, ma in generale di una tradizione folk&country da
fare a pezzi per essere riportata alla luce. Il primo schizzo
del gruppo, dopo essersi conosciuti fra le onde della radio del
campus universitario, è del 1984, sempre ancorato da qui in poi
alla coppia di chitarre Kyser-Kunkel e sballottato da diversi
rimpasti nel resto della formazione, approcciando da subito l'eredità
del passato e il presente del post punk losangelino con una visione
obliqua, una tensione distorta e alienata che li rende dissimili
da ogni possibile raffronto con i colleghi. Forse soltanto lontamente
sfiorati da una somigliante ispirazione, sghemba e inesplicabile,
con i Giant Sand di Howe Gelb, complici nel far sorgere la sigla
del desert rock dalla confinante scena di Tucson, Arizona, i Thin
White Rope svelano immediatamente una dipendenza assoluta
dalle forze della natura.
Proprio così: la formazione di geologo di Guy Kyser, una laurea
che sfrutterà solo in seguito- dopo avere abbandonato con una
scelta quasi definitiva la carriera musicale - si traduce in una
musica di elementi e mistero, in testi e figure ambigue, tortuosi
nei sentimenti e nelle immagini evocate, in un rock della frontiera
che espande, quasi ingigantisce l'eco della sabbia e del deserto
americano mettendo insieme chitarre fragorose e ai limiti dell'hard
con gli intrecci celebrali dei Television e naturalmente l'eredità
della psichedelia di fine sixties. Ma nei rimpalli fra Kunkel
e Kyser, nelle loro sei corde acide, roboanti e invase dal feedback
risiede una cruda potenza che è probabilmente più figlia del punk,
di certo dark e certamente del Neil Young accecato dalle visioni
di Zuma. Quasi inevitabile questo cortocircuito, accresciuto nei
primi dischi dall'intesa con i tamburi di Josef Becker, la cui
dipartita si rivelerà poi la chiave per una maturazione più consapevole
della band, lanciata anche nei territori solenni e spiritati del
kraut rock (proporanno una cover di You Do Right dei Can).
Nonostante
però la firma per la Frontier, etichetta della Sun valley che
guida le fila della insurrezione punk con gruppi quali Circle
jerks e Adolescents in scuderia, i Thin White Rope sembrano destinati
fin dal principio ad una lenta, impenetrabile indifferenza, un
magma scuro molto simile alle loro canzoni, le stesse che li spingono
verso quell'ignoto da cui non pare possano fare ritorno. È la
stessa voce di Guy Kyser, tesa come una corda, vibrante,
un rigurgito frenetico e minaccioso, che esprime la tensione metallica,
costantemente sull'orlo di un precipizio, della loro musica. Riconosciuti
con il senno di poi come una delle realtà più eccitanti che il
giovane rock americano della prima metà degli anni ottanta possa
offrire alla sua storia, seguiranno tuttavia un percorso quasi
isolato rispetto anche ad altre compagini nate in quel grande
contesto artistico del citato Paisley. Nessuna collaborazione
significativa ad esempio nel loro decennio di peregrinazioni:
mentre Dream Syndicate, Green on Red, Long Ryders, True West ed
altri incrociano spesso i propri destini, si prestano canzoni,
progetti e chitarre, Kyser e soci si eclissano nel deserto, è
proprio il caso di dirlo, raggiungendo un ruolo di autentica venerazione
soprattutto in Europa.
Affronteranno infatti una serie di tour, anche nell'Est ancora
soggiogato alla cortina di ferro, mostrando forse al pubblico
continentale (Germania, Belgio e Francia alcune delle loro roccaforti)
un fascino tutto "americano" fra suoni e immagini, che altre formazioni
non riescono al tempo a permeare con altrettanta efficacia. Il
doppio dal vivo The One that Got Away, registrato proprio
nel corso di un tour europeo del 1992, sancirà dunque platealmente
la fine del loro ostinato cammino: senza proclami, invettive,
con la serietà e l'intensa concentrazione espressa nei loro dischi,
rompono le righe dandosi appuntamento in un'altra era, quasi che
la musica dei Thin White Rope appartenesse davvero alla natura
e allo spirito della terra che hanno loro stessi evocato.
|
 |
Moonhead
[Frontier,
1987]
1. Not Your Fault ///
2. Wire Animals // 3. Take It Home // 4. Thing // 5. Moonhead // 6. Wet Heart
// 7. Mother // 8. Come Around // 9. Those Tears // 10. Crawl Piss Freeze |
| | |
Nascosti alla vista, nel subbuglio che il cosiddetto alternative
rock americano sta vivendo con la sua stagione cruciale (il passaggio dall'oscurità
dell'undergournd alle insistenti attenzioni delle grandi etichette) i Thin
White Rope sono ancora una volta ai margini della strada, sul lato oscuro
e perdente del sogno americano. Le canzoni di Moonhead riflettono
questa condizione con un sentimento di malinconia e rivalsa al tempo stesso, un
tumulto di rimorsi, ricordi, desideri che Guy Kyser traduce in canzoni più personali
rispetto all'esordio. Per questo il disco si mostra con due facce: quella in fondo
intima, a cuore aperto, intensamente umorale delle liriche e quella spietata,
ruvida, compatta del suono, oggi più che mai all'apice di uno stile definito.
In un tempo che vede trionfare la rabbia di Minneapolis con Husker Du e Replacements,
mentre il Paisley si lecca le ferite e stimoli imprevisti fuoriescono dal nuovo
rock di Sonic Youth, Pixies e Dinosaur Jr, Moonhead è semplicemente uno splendido,
isolato fragore, una roccia elettrica in cui la band si addensa nella coltre di
Not Your Fault e Wire
Animals. I Thin White Rope non sono mai stati così precisi ed essenziali:
i primi due brani sintetizzano gli stridori post punk del gruppo con un rock che
ora si è fatto più consapevole e adulto. Ma la natura di Moonhead è esattamente
la sua "lunatica" e misteriosa andatura, il percorrere un sentiero dentro e fuori
la tradizione con un'indipendenza coraggiosa. Solo così si spiega la tremante
sospensione che una ballata come Thing imprime
all'intera interpretazione di Guy Kyser: è una country song vecchia come il mondo,
arriva da un tempo indefinito e implode in un finale dove la solitudine acustica
viene spezzata dal crepitare di una lontana chitarra elettrica. Il lascito della
psichedelia e delle trame chitarristiche non è affatto abbandonato: occorrono
due minuti abbondanti di improvvisazione prima che Moonhead,
la title track, esploda nel suo incedere. È l'intero corpo centrale dell'album
a decifrare lo stile errante dei Thin White Rope: la neo psichedelia e il rock
desertico di cui si andava favoleggiando al debutto qui si trasforma in qualcosa
di sinistro, serpeggiante, persino disturbante (Crawl
Piss Freeze) una sorta di magma rock che porta il nome di Wet
Heart, Mother, If
Those Tears, dell'esplosiva Come Around,
conducendo il gruppo verso territori sempre più inesplorati. Nella ristampa proposta
qualche anno dopo dalla Frontier ci sarà spazio per inserire i brani dal succesisvo
ep Bottom Feeders (di cui vi diamo conto in seguito), ma soprattutto per assaporare
gli scroscianti sei minuti di tensione in Take It Home,
capolavoro misconosciuto in cui la densità delle chitarre di Kyser e Kunkel tocca
il vertice. | |
| |
|  Exploring the Axis [Frontier, 1985]
Exploring the Axis [Frontier, 1985]
 L'esordio
è già leggenda, totalmente compiuto, contenendo tutti gli elementi che sapranno
contraddistinguere il flusso di immagini e suoni dei Thin White Rope. Non
sembra affatto l'opera prima di uno sparuto gruppo di sperimentatori della nuova
onda psichedelica californiana, quanto un diamante già perfettamente scolpito
di intrecci chitarristici, ballate spettrali e stridenti feedback che incontrano
al largo persino la tradizone country&western così come il punk celebrale dei
Television. È questo forse l'elemento "esotico" e imprevedibile che fa scomodare
la definizione di desert rock, tra il caracollare di
Dead Grammas on a Train, sorta di Johnny Cash sovraeccitato che viaggia
in acido sommerso da chitarre colme di riverberi, e gli stridori metallici e le
accelerazioni pronti a deflaglare in Soundtrack,
Eleven e Macy's
Window. Nel mezzo una prospettiva personale e spigolosa per rilanciare
il verbo della psichedelia, con il quale Exploring the Axis amoreggia senza dubbio
con più coinvolgimento e devozione per le lezioni del passato rispetto al resto
della loro produzione successiva: il ritmo marziale di Down
in the Desert, l'allucinato reticolo di feedback chitarristici e le
frementi parole in Disney Girl, il minaccioso
orizzonte di Atomic Imagery, il sinistro rintocco
di Lithium e la passione più terrena di The
Real West, sono nel complesso titoli e canzoni che parlano da soli,
manifesto di una band che ridà lustro ad un lontano tragitto della musica californiana,
confondendo forse in principio la stessa critica. Il confronto con il Paisley
Undeground è dietro l'angolo e nasce spontaneo (la title track echeggia esplicitamente
un sentire comune con il debutto dei Dream Syndicate, va ammesso), e tuttavia
le storie di isolamento, alienazione, i continui subbugli interiori e il dominio
tetro della natura sull'animo umano svelano già in Guy Kyser, nella sua voce turbata
e nelle visioni che regala al resto della band (il nucleo originario sarà completato,
oltre che dal fedele partner Roger Kunkel, dalla batteria di Josef Becker e dal
basso di Stephen Tesluk), un percorso unico e interamente non catalogabile. La
produzione di Jeff Eyrich (nome familiare al tempo grazie alle produzioni
di Gun Club e Plimsouls), nonostante i segni del tempo, mantiene la sensibilità
e il rispetto per lasciare galoppare libero il fiotto chitarristico dei Thin White
Rope, anche nelle sue asperità. Il viaggio nel deserto è appena iniziato. L'esordio
è già leggenda, totalmente compiuto, contenendo tutti gli elementi che sapranno
contraddistinguere il flusso di immagini e suoni dei Thin White Rope. Non
sembra affatto l'opera prima di uno sparuto gruppo di sperimentatori della nuova
onda psichedelica californiana, quanto un diamante già perfettamente scolpito
di intrecci chitarristici, ballate spettrali e stridenti feedback che incontrano
al largo persino la tradizone country&western così come il punk celebrale dei
Television. È questo forse l'elemento "esotico" e imprevedibile che fa scomodare
la definizione di desert rock, tra il caracollare di
Dead Grammas on a Train, sorta di Johnny Cash sovraeccitato che viaggia
in acido sommerso da chitarre colme di riverberi, e gli stridori metallici e le
accelerazioni pronti a deflaglare in Soundtrack,
Eleven e Macy's
Window. Nel mezzo una prospettiva personale e spigolosa per rilanciare
il verbo della psichedelia, con il quale Exploring the Axis amoreggia senza dubbio
con più coinvolgimento e devozione per le lezioni del passato rispetto al resto
della loro produzione successiva: il ritmo marziale di Down
in the Desert, l'allucinato reticolo di feedback chitarristici e le
frementi parole in Disney Girl, il minaccioso
orizzonte di Atomic Imagery, il sinistro rintocco
di Lithium e la passione più terrena di The
Real West, sono nel complesso titoli e canzoni che parlano da soli,
manifesto di una band che ridà lustro ad un lontano tragitto della musica californiana,
confondendo forse in principio la stessa critica. Il confronto con il Paisley
Undeground è dietro l'angolo e nasce spontaneo (la title track echeggia esplicitamente
un sentire comune con il debutto dei Dream Syndicate, va ammesso), e tuttavia
le storie di isolamento, alienazione, i continui subbugli interiori e il dominio
tetro della natura sull'animo umano svelano già in Guy Kyser, nella sua voce turbata
e nelle visioni che regala al resto della band (il nucleo originario sarà completato,
oltre che dal fedele partner Roger Kunkel, dalla batteria di Josef Becker e dal
basso di Stephen Tesluk), un percorso unico e interamente non catalogabile. La
produzione di Jeff Eyrich (nome familiare al tempo grazie alle produzioni
di Gun Club e Plimsouls), nonostante i segni del tempo, mantiene la sensibilità
e il rispetto per lasciare galoppare libero il fiotto chitarristico dei Thin White
Rope, anche nelle sue asperità. Il viaggio nel deserto è appena iniziato.
 In the Spanish Cave [Frontier, 1988]
In the Spanish Cave [Frontier, 1988]
 Grazie
ad una delle copertine più prodigiose del periodo, In The Spanish Cave
è alternativamente considerato un punto di arrivo e un momento di passaggio nella
storia dei Thin White Rope (John Von Fledt è definitivamente il nuovo bassista,
mentre il batterista Josef Becker abbandonerà purtroppo a disco finito). In tutto
e per tutto pervaso dalla stessa impenetrabile bellezza dei primi lavori, il disco
ha tuttavia sofferto con il passare del tempo degli effetti di una produzione
frettolosa, segnata oltre misura da alcune delle manie da "big sound" tipiche
del periodo: lo stesso Paul McKenna di Moonhead siede in regia, ma insieme
alla band chiude il disco con un budget ristretto e soprattutto con il fiato corto
per il tour precedente. Da un certo punto di vista ne guadagna la compattezza
sonora accomulata sul palco, un monolite elettrico mai così efficace: In the Spanish
Cave contiene infatti alcune delle canzoni più crude del loro repertorio, che
diventeranno di fatto autentici cavalli di battaglia, a cominciare dalla rabbia
travolgente con cui Kyser aggredisce il clangore metallico di It's
Ok. Con quest'ultima formano un vero e proprio muro di suono la corsa
a rotta di collo di Elsie Crashed the Party,
anima punk che schizza come una scheggia impazzita lungo i feedback delle chitarre,
e ancora l'incedere blues sinistro di Wand.
Rappresentano nell'insieme gli episodi più di pelle, istintivi, di un disco che
espande invece alcune delle tematiche degli album precedenti con risultati inaspettati
per costruzione lirica e per sfumature degli arrangiamenti: non ti aspetteresti
ad esempio il caracollare country&western di Mr. Limpet
e la sua pungente ironia, che apre il disco all'insegna del verbo roots rock che
in quegli anni si è impossessato di parte della scena alternativa americana, oppure
ancora la sua evoluzione in chiave elettrica e stentorea in Timing.
Nonostante tutto però il fascino di In the Spanish Cave, disco senza dubbio meno
sinuoso e assai più ruvido dei predecessori, risiede ancora nelle spirali di neo-psichedelia
che arroventano il suono in Red Sun, vero
fulcro e possibile capolavoro del disco, marchio della musica "desertica" della
band, da assaporare anche nella sua versione più onirica in Ring
e Astronomy. Grazie
ad una delle copertine più prodigiose del periodo, In The Spanish Cave
è alternativamente considerato un punto di arrivo e un momento di passaggio nella
storia dei Thin White Rope (John Von Fledt è definitivamente il nuovo bassista,
mentre il batterista Josef Becker abbandonerà purtroppo a disco finito). In tutto
e per tutto pervaso dalla stessa impenetrabile bellezza dei primi lavori, il disco
ha tuttavia sofferto con il passare del tempo degli effetti di una produzione
frettolosa, segnata oltre misura da alcune delle manie da "big sound" tipiche
del periodo: lo stesso Paul McKenna di Moonhead siede in regia, ma insieme
alla band chiude il disco con un budget ristretto e soprattutto con il fiato corto
per il tour precedente. Da un certo punto di vista ne guadagna la compattezza
sonora accomulata sul palco, un monolite elettrico mai così efficace: In the Spanish
Cave contiene infatti alcune delle canzoni più crude del loro repertorio, che
diventeranno di fatto autentici cavalli di battaglia, a cominciare dalla rabbia
travolgente con cui Kyser aggredisce il clangore metallico di It's
Ok. Con quest'ultima formano un vero e proprio muro di suono la corsa
a rotta di collo di Elsie Crashed the Party,
anima punk che schizza come una scheggia impazzita lungo i feedback delle chitarre,
e ancora l'incedere blues sinistro di Wand.
Rappresentano nell'insieme gli episodi più di pelle, istintivi, di un disco che
espande invece alcune delle tematiche degli album precedenti con risultati inaspettati
per costruzione lirica e per sfumature degli arrangiamenti: non ti aspetteresti
ad esempio il caracollare country&western di Mr. Limpet
e la sua pungente ironia, che apre il disco all'insegna del verbo roots rock che
in quegli anni si è impossessato di parte della scena alternativa americana, oppure
ancora la sua evoluzione in chiave elettrica e stentorea in Timing.
Nonostante tutto però il fascino di In the Spanish Cave, disco senza dubbio meno
sinuoso e assai più ruvido dei predecessori, risiede ancora nelle spirali di neo-psichedelia
che arroventano il suono in Red Sun, vero
fulcro e possibile capolavoro del disco, marchio della musica "desertica" della
band, da assaporare anche nella sua versione più onirica in Ring
e Astronomy.
 Sack Full of Silver [Frontier, 1990]
Sack Full of Silver [Frontier, 1990]
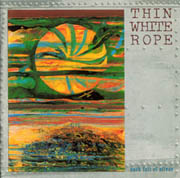 Come
sottolineano le stesse note interne al cd curate dal gruppo, Sack Full of
Silver è il primo lavoro dei Thin White Rope a germogliare "sulla
strada", con tutte le conseguenze che solitamente comporta una simile operazione.
Tuttavia, per nulla raffazzonato o schiacciato da esigenze di tempo (il produttore
è Tom Mallon, già al fianco degli American Music Club), l'album rappresenta un
momento di estrema maturità e concisione, in cui la band sembra fare tesoro del
proprio passato, per riassumere con rara e assoluta accuratezza il senso ultimo
del proprio stile. La lunga tournè mondiale dunque è servita a Guy Kyser e soci
per stratificare ulteriormente il rock di frontiera che soffiava polvere e desolazione
nei lavori precedenti, dando vita in Sack Full of Silver ad una splendida mediazione:
da una parte lo sperimentalismo, le trame psichedeliche e la "follia" ordinata
dei feedback (qui riassunti nella concisa riedizione di You
Doo Right dei Can e ancora di più nei tuoni elettrici di Diesel
Man), dall'altra, in netta prevalenza, l'afflato quasi neo-tradizionalista
che popola le nuove ballate di Kyser. Si sarebbe parlato al tempo di roots rock,
anche se non è sbagliato leggere in controluce nella meravigliosa e diafana title
track, con tanto di accordion, e più ancora nel cristallino folk rock di Americana
(un titolo premonitore) e On The Floe, o ancora
nella dolcissima maliconia di Triangle, le
avvisaglie della successiva rivoluzione chiamata alternative country. I Thin White
Rope abitano ancora la terra di nessuno del deserto americano, solanto questa
volta con una saggezza che li avvicina ai classici, come se Guy Kyser avesse scoperto
finalmente la voce del passato che lo chiamava dai luoghi oscuri americani (dell'anima
e del paesaggio, sempre così connessi nella sua scrittura). Disco di una bellezza
nostalgica, Sack Full of Silver è l'ultimo anello di una sequenza di capolavori
ignorati: avrà l'onore di una fugace prima distribuzione su major, prima di tornare
velocemente nelle mani della chioccia Frontier, dentro quella semi-oscurità a
cui il gruppo è stato destinato fin dal principio. Come
sottolineano le stesse note interne al cd curate dal gruppo, Sack Full of
Silver è il primo lavoro dei Thin White Rope a germogliare "sulla
strada", con tutte le conseguenze che solitamente comporta una simile operazione.
Tuttavia, per nulla raffazzonato o schiacciato da esigenze di tempo (il produttore
è Tom Mallon, già al fianco degli American Music Club), l'album rappresenta un
momento di estrema maturità e concisione, in cui la band sembra fare tesoro del
proprio passato, per riassumere con rara e assoluta accuratezza il senso ultimo
del proprio stile. La lunga tournè mondiale dunque è servita a Guy Kyser e soci
per stratificare ulteriormente il rock di frontiera che soffiava polvere e desolazione
nei lavori precedenti, dando vita in Sack Full of Silver ad una splendida mediazione:
da una parte lo sperimentalismo, le trame psichedeliche e la "follia" ordinata
dei feedback (qui riassunti nella concisa riedizione di You
Doo Right dei Can e ancora di più nei tuoni elettrici di Diesel
Man), dall'altra, in netta prevalenza, l'afflato quasi neo-tradizionalista
che popola le nuove ballate di Kyser. Si sarebbe parlato al tempo di roots rock,
anche se non è sbagliato leggere in controluce nella meravigliosa e diafana title
track, con tanto di accordion, e più ancora nel cristallino folk rock di Americana
(un titolo premonitore) e On The Floe, o ancora
nella dolcissima maliconia di Triangle, le
avvisaglie della successiva rivoluzione chiamata alternative country. I Thin White
Rope abitano ancora la terra di nessuno del deserto americano, solanto questa
volta con una saggezza che li avvicina ai classici, come se Guy Kyser avesse scoperto
finalmente la voce del passato che lo chiamava dai luoghi oscuri americani (dell'anima
e del paesaggio, sempre così connessi nella sua scrittura). Disco di una bellezza
nostalgica, Sack Full of Silver è l'ultimo anello di una sequenza di capolavori
ignorati: avrà l'onore di una fugace prima distribuzione su major, prima di tornare
velocemente nelle mani della chioccia Frontier, dentro quella semi-oscurità a
cui il gruppo è stato destinato fin dal principio.
| | |
| | | |
|
 The Ruby Sea
[Frontier, 1991] The Ruby Sea
[Frontier, 1991]
 Curioso
che a chiudere l'avventura in studio dei Thin White Rope sia forse il loro
disco meno sorpredente: tutto ciò non significa che con gli anni The Ruby
Sea non abbia riacquistato un fascino che al tempo era sembrato scolorirsi
di fronte alla bellezza spaventosa di Sack Full of Silver e In The Spanish Cave.
La band è nuovamente rivoluzionata nella sezione ritmica (Matthew Abourezk dietro
i tamburi, Stooert Odom al basso), forse incidendo sull'intesa immediata in studio
di registrazione: lavorando con Bill Noland (già al fianco di Stan Ridgway) i
Thin White Rope sembrano semplicemente fare tesoro delle conquiste del passato,
per la prima volta più "normali" del previsto, assecondando un suono che si è
fatto via via più monolitico, intensamente rock, ma dalle tinte scure, quasi gotiche,
spesso tralasciando il garbuglio chitarristico degli esordi. È quasi un disco
di frammenti, idee e intuizioni, spesso non perfette, ma capace di svelare angoli
nascosti, strane deviazioni di percorso, che qui prendono il titolo di Puppet
Dog, The Fish Song, sfiorando ancora
i sentieri della tradizione ma sfregiandoli nell'incedere di Tina
and Glen, dell'ubriaca Christmas Skies
o ancora di The Clown Song. La sfortuna di
The Ruby Sea è forse di non possedere la compattezza granitica di In The Spanish
Cave, né tanto meno le canzoni spericolate di Moonhead. È soltanto il ritratto
di un gruppo che ha raggiunto la una rappacificata maturità, può concedersi, per
quanto sia possibile applicare tale definizione ai Thin White Rope, di fare accademia
o più naturalmente di aspettare il raccolto migliore. In ogni caso non viene meno
il coraggio per l'ignoto: si chiama Dinosaur
ed è una specie di scheletro di canzone, qualcosa che approda al grado zero della
loro scrittura, una rarefazione del loro stile che fra una batteria e una tastiera
produce una eco lontana. Sarà anche l'ultimo segnale lanciato dal deserto del
Mojave verso l'infinito dell'universo, là dove idealmente risiedono i suoni e
l'immaginario del gruppo. Curioso
che a chiudere l'avventura in studio dei Thin White Rope sia forse il loro
disco meno sorpredente: tutto ciò non significa che con gli anni The Ruby
Sea non abbia riacquistato un fascino che al tempo era sembrato scolorirsi
di fronte alla bellezza spaventosa di Sack Full of Silver e In The Spanish Cave.
La band è nuovamente rivoluzionata nella sezione ritmica (Matthew Abourezk dietro
i tamburi, Stooert Odom al basso), forse incidendo sull'intesa immediata in studio
di registrazione: lavorando con Bill Noland (già al fianco di Stan Ridgway) i
Thin White Rope sembrano semplicemente fare tesoro delle conquiste del passato,
per la prima volta più "normali" del previsto, assecondando un suono che si è
fatto via via più monolitico, intensamente rock, ma dalle tinte scure, quasi gotiche,
spesso tralasciando il garbuglio chitarristico degli esordi. È quasi un disco
di frammenti, idee e intuizioni, spesso non perfette, ma capace di svelare angoli
nascosti, strane deviazioni di percorso, che qui prendono il titolo di Puppet
Dog, The Fish Song, sfiorando ancora
i sentieri della tradizione ma sfregiandoli nell'incedere di Tina
and Glen, dell'ubriaca Christmas Skies
o ancora di The Clown Song. La sfortuna di
The Ruby Sea è forse di non possedere la compattezza granitica di In The Spanish
Cave, né tanto meno le canzoni spericolate di Moonhead. È soltanto il ritratto
di un gruppo che ha raggiunto la una rappacificata maturità, può concedersi, per
quanto sia possibile applicare tale definizione ai Thin White Rope, di fare accademia
o più naturalmente di aspettare il raccolto migliore. In ogni caso non viene meno
il coraggio per l'ignoto: si chiama Dinosaur
ed è una specie di scheletro di canzone, qualcosa che approda al grado zero della
loro scrittura, una rarefazione del loro stile che fra una batteria e una tastiera
produce una eco lontana. Sarà anche l'ultimo segnale lanciato dal deserto del
Mojave verso l'infinito dell'universo, là dove idealmente risiedono i suoni e
l'immaginario del gruppo.
 The One That Got Away [Frontier, 1993]
The One That Got Away [Frontier, 1993]
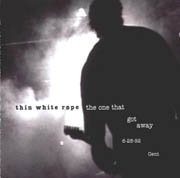 Il
sipario cala sulla storia dei Thin White Rope con un maestoso doppio disco
dal vivo registrato in un'unica serata: è lo show finale del 28 giugno 1992 tra
le mura del piccolo e infuocato club Democrazee di Gent, Belgio, a dimostrazione
una volta di più di quanto la band californiana sia stata accolta con tutti i
favori soprattutto dal pubblico underground europeo. The One That Got Away
può vantare una coesione eccezionale, senza abbellimenti e sotterfugi che ne modifichino
la struttura, ma semmai raccontino con cruda verità il "wall of sound"
chitarristico a cui la band è approdata nel corso del tempo. Ventisei canzoni,
due ore travolgenti su cui scorre uno strano senso di rabbia, un risentimento
malinconico in chi ha potuto scorgere la grandezza del gruppo in quell'istante
e non capacitarsi della quasi totale indifferenza: Kyser canta con una consapevolezza
della sconfitta che trascina con sé forza e sicurezza, come se il compito dei
Thin White Rope si fosse esaurito senza rimpianti. Ha ragione da vendere. Le verisoni
di Down in the Desert, Wire
Animals, Disney Girl e Astronomy
sembrano quelle definitive, portando a compimento la sintesi tra muscoli e cervello
della coppia di chitarre con Roger Kunkel, mentre l'ennesima sezione ritmica in
divenire (alla batteria ora siede per il tour europeo Stooert Odom) "devasta"
come una furia il repertorio. Qui le riletture di Take
It home e Triangle Song, o ancora
Tina and Glen paiono affermare l'ultima parola
sull'arte dei Thin White Rope, mentre la scaletta si arrichisce di sorprese e
chicche che saranno riservate alle varie raccolte di outtake: dal mazzo scegliamo
per la cronaca Some Velvet Morning, la dylaniana
Outlaw Blues, anche se l'imprevedile si annida
nella riproposizione di Roadrunner di Bo Diddley,
spogliata del beat originario e assai più sinistra, o ancora nel country rock
selvaggio del traditional Wreck of the Ol' 97. Il
sipario cala sulla storia dei Thin White Rope con un maestoso doppio disco
dal vivo registrato in un'unica serata: è lo show finale del 28 giugno 1992 tra
le mura del piccolo e infuocato club Democrazee di Gent, Belgio, a dimostrazione
una volta di più di quanto la band californiana sia stata accolta con tutti i
favori soprattutto dal pubblico underground europeo. The One That Got Away
può vantare una coesione eccezionale, senza abbellimenti e sotterfugi che ne modifichino
la struttura, ma semmai raccontino con cruda verità il "wall of sound"
chitarristico a cui la band è approdata nel corso del tempo. Ventisei canzoni,
due ore travolgenti su cui scorre uno strano senso di rabbia, un risentimento
malinconico in chi ha potuto scorgere la grandezza del gruppo in quell'istante
e non capacitarsi della quasi totale indifferenza: Kyser canta con una consapevolezza
della sconfitta che trascina con sé forza e sicurezza, come se il compito dei
Thin White Rope si fosse esaurito senza rimpianti. Ha ragione da vendere. Le verisoni
di Down in the Desert, Wire
Animals, Disney Girl e Astronomy
sembrano quelle definitive, portando a compimento la sintesi tra muscoli e cervello
della coppia di chitarre con Roger Kunkel, mentre l'ennesima sezione ritmica in
divenire (alla batteria ora siede per il tour europeo Stooert Odom) "devasta"
come una furia il repertorio. Qui le riletture di Take
It home e Triangle Song, o ancora
Tina and Glen paiono affermare l'ultima parola
sull'arte dei Thin White Rope, mentre la scaletta si arrichisce di sorprese e
chicche che saranno riservate alle varie raccolte di outtake: dal mazzo scegliamo
per la cronaca Some Velvet Morning, la dylaniana
Outlaw Blues, anche se l'imprevedile si annida
nella riproposizione di Roadrunner di Bo Diddley,
spogliata del beat originario e assai più sinistra, o ancora nel country rock
selvaggio del traditional Wreck of the Ol' 97.
 Bottom Feeders
[Zane, 1987] Bottom Feeders
[Zane, 1987]
 Red Sun [Vex, 1988]
Red Sun [Vex, 1988]
 Squatter's Rights [Frontier, 1991]
Squatter's Rights [Frontier, 1991]
 Spoor
[Frontier, 1995] Spoor
[Frontier, 1995]
 Attività
a cui si sono sempre concessi volentieri, quella dell'ep è nella carriera dei
Thin White Rope quasi una necessità per agire da raccordo nella loro evoluzione
stilistica: spesso e volentieri si tratta di assolute gemme, per fortuna recuperate
nelle numerose ristampe su cd sia per la Demon europea, sia per l'originale etichetta
americana della Frontier. Popolati da cover illuminanti, inediti, outtakes, brani
che verranno poi rivisitati anche dal vivo, questi extended play possiedono la
magia per svelare la natura multiforme della band. Bottom Feeders,
ancora illuminato da un delizioso disegno di copertina che farà da collegamento
per la nave dei pirati di In the Spanish Cave, si apre con una spiazzante Ain't
That Lovin You baby, blues di Jimmy Reed trasformato in un rantolo
tra punk rock e Elvis Presley, e si chiude sulle note dal vivo di Rocket
Usa dei Suicide. Come dire: lo ying e lo yang del rock'n'roll. Il resto
sarà in parte recuperato nella scaletta di Moonhead (la sinuosa Waking
Up), alle cui atmosfere di straniante desert rock molto del materiale
rimanda: l'incedere honky tonk allucinato di Valley of
the Bones, altro omaggio malcelato a Johnny Cash, ma soprattutto il
diamante post punk di Atomic Imagery. Red Sun sarà se possibile
ancora più indicativo delle future direzioni della band: concepito inizialmente
come colonna sonora per uno stravagante film di avanguardia, un bianco e nero
la cui pellicola viene poi dipinta di arancione dando la sensazione alienante
e post-nucleare in cui si svolge la strampalata storia, l'album raccoglie una
versione acustica della title track, poi arrangiata per In The Spanish Cave, ma
soprattutto una serie di cover a dir poco esplicative, segnali per la svolta roots
di Sack Full of Silver. Si comincia con una improbabile Town
Without Pity, canzone dall'omonimo film con Kirk Douglas interpretata
da Gene Pitney e si finisce con la classica Some Velvet
Morning di Lee Hazlewood, qui schiacciata da tonnellate di feedback.
Nel mezzo la saga western di The Man with the Golden
Gun (da una colonna sonora di James Bond) e il capolavoro They're
Hanging me Tonight trata direttamente dall'indimenticabile Marty Robbins
delle Gunfighter Ballads. Squatter's Right del 1991 chiuderà questa
consuetudine di ep allineando una nuova serie di "inverosimili" cover, dalle quali
la band sembra attingere ispirazione e divertimento al tempo stesso: questa volta
tocca al'immortale Caravan di Duke Ellington,
una più prevedibile Roadrunner a firma Bo
Diddley, May This Be Love di Jimi Hendrix
(dal disco tributo If 6 was 9) e l'accoppiata Everybody's
Been Burned e I Knew I'd Want You
utilizzata per l'omaggio di band dell'area alternative rock ai Byrds, intitolato
Time Between. Una parte di questo materiale - in particolar modo l'intero ep Red
Sun - verrà recuperata nella scaletta di Spoor, classica compilazione
di inediti e rarità che nel 1995 la Frontier immette sul mercato colmando ormai
il silenzio della band, scioltasi due anni prima con l'epitaffio dal vivo The
One That Got Away. Prodotto per appassionati ed estimatori assuefatti dunque,
anche se le presenze di Outlaw Blues di Bob
Dylan e Burn The Flames di Roky Erckson, entrambe
ripescate dalla lunga moda di tributi sorta nei primi anni '90, sono appetitose
chicche che contribuiscono in fondo a chiarire una volta di più le coordinate
stilistiche e le isprazioni dei Thin White Rope. Quello che avanza è certamente
più trascurabile, fra brani dal vivo e demo che, aumetando la confusione, saranno
ripescate per una ristampa europea di Moonhead ad opera della Diablo. Attività
a cui si sono sempre concessi volentieri, quella dell'ep è nella carriera dei
Thin White Rope quasi una necessità per agire da raccordo nella loro evoluzione
stilistica: spesso e volentieri si tratta di assolute gemme, per fortuna recuperate
nelle numerose ristampe su cd sia per la Demon europea, sia per l'originale etichetta
americana della Frontier. Popolati da cover illuminanti, inediti, outtakes, brani
che verranno poi rivisitati anche dal vivo, questi extended play possiedono la
magia per svelare la natura multiforme della band. Bottom Feeders,
ancora illuminato da un delizioso disegno di copertina che farà da collegamento
per la nave dei pirati di In the Spanish Cave, si apre con una spiazzante Ain't
That Lovin You baby, blues di Jimmy Reed trasformato in un rantolo
tra punk rock e Elvis Presley, e si chiude sulle note dal vivo di Rocket
Usa dei Suicide. Come dire: lo ying e lo yang del rock'n'roll. Il resto
sarà in parte recuperato nella scaletta di Moonhead (la sinuosa Waking
Up), alle cui atmosfere di straniante desert rock molto del materiale
rimanda: l'incedere honky tonk allucinato di Valley of
the Bones, altro omaggio malcelato a Johnny Cash, ma soprattutto il
diamante post punk di Atomic Imagery. Red Sun sarà se possibile
ancora più indicativo delle future direzioni della band: concepito inizialmente
come colonna sonora per uno stravagante film di avanguardia, un bianco e nero
la cui pellicola viene poi dipinta di arancione dando la sensazione alienante
e post-nucleare in cui si svolge la strampalata storia, l'album raccoglie una
versione acustica della title track, poi arrangiata per In The Spanish Cave, ma
soprattutto una serie di cover a dir poco esplicative, segnali per la svolta roots
di Sack Full of Silver. Si comincia con una improbabile Town
Without Pity, canzone dall'omonimo film con Kirk Douglas interpretata
da Gene Pitney e si finisce con la classica Some Velvet
Morning di Lee Hazlewood, qui schiacciata da tonnellate di feedback.
Nel mezzo la saga western di The Man with the Golden
Gun (da una colonna sonora di James Bond) e il capolavoro They're
Hanging me Tonight trata direttamente dall'indimenticabile Marty Robbins
delle Gunfighter Ballads. Squatter's Right del 1991 chiuderà questa
consuetudine di ep allineando una nuova serie di "inverosimili" cover, dalle quali
la band sembra attingere ispirazione e divertimento al tempo stesso: questa volta
tocca al'immortale Caravan di Duke Ellington,
una più prevedibile Roadrunner a firma Bo
Diddley, May This Be Love di Jimi Hendrix
(dal disco tributo If 6 was 9) e l'accoppiata Everybody's
Been Burned e I Knew I'd Want You
utilizzata per l'omaggio di band dell'area alternative rock ai Byrds, intitolato
Time Between. Una parte di questo materiale - in particolar modo l'intero ep Red
Sun - verrà recuperata nella scaletta di Spoor, classica compilazione
di inediti e rarità che nel 1995 la Frontier immette sul mercato colmando ormai
il silenzio della band, scioltasi due anni prima con l'epitaffio dal vivo The
One That Got Away. Prodotto per appassionati ed estimatori assuefatti dunque,
anche se le presenze di Outlaw Blues di Bob
Dylan e Burn The Flames di Roky Erckson, entrambe
ripescate dalla lunga moda di tributi sorta nei primi anni '90, sono appetitose
chicche che contribuiscono in fondo a chiarire una volta di più le coordinate
stilistiche e le isprazioni dei Thin White Rope. Quello che avanza è certamente
più trascurabile, fra brani dal vivo e demo che, aumetando la confusione, saranno
ripescate per una ristampa europea di Moonhead ad opera della Diablo. |
| | |

 L'esordio
è già leggenda, totalmente compiuto, contenendo tutti gli elementi che sapranno
contraddistinguere il flusso di immagini e suoni dei Thin White Rope. Non
sembra affatto l'opera prima di uno sparuto gruppo di sperimentatori della nuova
onda psichedelica californiana, quanto un diamante già perfettamente scolpito
di intrecci chitarristici, ballate spettrali e stridenti feedback che incontrano
al largo persino la tradizone country&western così come il punk celebrale dei
Television. È questo forse l'elemento "esotico" e imprevedibile che fa scomodare
la definizione di desert rock, tra il caracollare di
Dead Grammas on a Train, sorta di Johnny Cash sovraeccitato che viaggia
in acido sommerso da chitarre colme di riverberi, e gli stridori metallici e le
accelerazioni pronti a deflaglare in Soundtrack,
Eleven e Macy's
Window. Nel mezzo una prospettiva personale e spigolosa per rilanciare
il verbo della psichedelia, con il quale Exploring the Axis amoreggia senza dubbio
con più coinvolgimento e devozione per le lezioni del passato rispetto al resto
della loro produzione successiva: il ritmo marziale di Down
in the Desert, l'allucinato reticolo di feedback chitarristici e le
frementi parole in Disney Girl, il minaccioso
orizzonte di Atomic Imagery, il sinistro rintocco
di Lithium e la passione più terrena di The
Real West, sono nel complesso titoli e canzoni che parlano da soli,
manifesto di una band che ridà lustro ad un lontano tragitto della musica californiana,
confondendo forse in principio la stessa critica. Il confronto con il Paisley
Undeground è dietro l'angolo e nasce spontaneo (la title track echeggia esplicitamente
un sentire comune con il debutto dei Dream Syndicate, va ammesso), e tuttavia
le storie di isolamento, alienazione, i continui subbugli interiori e il dominio
tetro della natura sull'animo umano svelano già in Guy Kyser, nella sua voce turbata
e nelle visioni che regala al resto della band (il nucleo originario sarà completato,
oltre che dal fedele partner Roger Kunkel, dalla batteria di Josef Becker e dal
basso di Stephen Tesluk), un percorso unico e interamente non catalogabile. La
produzione di Jeff Eyrich (nome familiare al tempo grazie alle produzioni
di Gun Club e Plimsouls), nonostante i segni del tempo, mantiene la sensibilità
e il rispetto per lasciare galoppare libero il fiotto chitarristico dei Thin White
Rope, anche nelle sue asperità. Il viaggio nel deserto è appena iniziato.
L'esordio
è già leggenda, totalmente compiuto, contenendo tutti gli elementi che sapranno
contraddistinguere il flusso di immagini e suoni dei Thin White Rope. Non
sembra affatto l'opera prima di uno sparuto gruppo di sperimentatori della nuova
onda psichedelica californiana, quanto un diamante già perfettamente scolpito
di intrecci chitarristici, ballate spettrali e stridenti feedback che incontrano
al largo persino la tradizone country&western così come il punk celebrale dei
Television. È questo forse l'elemento "esotico" e imprevedibile che fa scomodare
la definizione di desert rock, tra il caracollare di
Dead Grammas on a Train, sorta di Johnny Cash sovraeccitato che viaggia
in acido sommerso da chitarre colme di riverberi, e gli stridori metallici e le
accelerazioni pronti a deflaglare in Soundtrack,
Eleven e Macy's
Window. Nel mezzo una prospettiva personale e spigolosa per rilanciare
il verbo della psichedelia, con il quale Exploring the Axis amoreggia senza dubbio
con più coinvolgimento e devozione per le lezioni del passato rispetto al resto
della loro produzione successiva: il ritmo marziale di Down
in the Desert, l'allucinato reticolo di feedback chitarristici e le
frementi parole in Disney Girl, il minaccioso
orizzonte di Atomic Imagery, il sinistro rintocco
di Lithium e la passione più terrena di The
Real West, sono nel complesso titoli e canzoni che parlano da soli,
manifesto di una band che ridà lustro ad un lontano tragitto della musica californiana,
confondendo forse in principio la stessa critica. Il confronto con il Paisley
Undeground è dietro l'angolo e nasce spontaneo (la title track echeggia esplicitamente
un sentire comune con il debutto dei Dream Syndicate, va ammesso), e tuttavia
le storie di isolamento, alienazione, i continui subbugli interiori e il dominio
tetro della natura sull'animo umano svelano già in Guy Kyser, nella sua voce turbata
e nelle visioni che regala al resto della band (il nucleo originario sarà completato,
oltre che dal fedele partner Roger Kunkel, dalla batteria di Josef Becker e dal
basso di Stephen Tesluk), un percorso unico e interamente non catalogabile. La
produzione di Jeff Eyrich (nome familiare al tempo grazie alle produzioni
di Gun Club e Plimsouls), nonostante i segni del tempo, mantiene la sensibilità
e il rispetto per lasciare galoppare libero il fiotto chitarristico dei Thin White
Rope, anche nelle sue asperità. Il viaggio nel deserto è appena iniziato. Grazie
ad una delle copertine più prodigiose del periodo, In The Spanish Cave
è alternativamente considerato un punto di arrivo e un momento di passaggio nella
storia dei Thin White Rope (John Von Fledt è definitivamente il nuovo bassista,
mentre il batterista Josef Becker abbandonerà purtroppo a disco finito). In tutto
e per tutto pervaso dalla stessa impenetrabile bellezza dei primi lavori, il disco
ha tuttavia sofferto con il passare del tempo degli effetti di una produzione
frettolosa, segnata oltre misura da alcune delle manie da "big sound" tipiche
del periodo: lo stesso Paul McKenna di Moonhead siede in regia, ma insieme
alla band chiude il disco con un budget ristretto e soprattutto con il fiato corto
per il tour precedente. Da un certo punto di vista ne guadagna la compattezza
sonora accomulata sul palco, un monolite elettrico mai così efficace: In the Spanish
Cave contiene infatti alcune delle canzoni più crude del loro repertorio, che
diventeranno di fatto autentici cavalli di battaglia, a cominciare dalla rabbia
travolgente con cui Kyser aggredisce il clangore metallico di It's
Ok. Con quest'ultima formano un vero e proprio muro di suono la corsa
a rotta di collo di Elsie Crashed the Party,
anima punk che schizza come una scheggia impazzita lungo i feedback delle chitarre,
e ancora l'incedere blues sinistro di Wand.
Rappresentano nell'insieme gli episodi più di pelle, istintivi, di un disco che
espande invece alcune delle tematiche degli album precedenti con risultati inaspettati
per costruzione lirica e per sfumature degli arrangiamenti: non ti aspetteresti
ad esempio il caracollare country&western di Mr. Limpet
e la sua pungente ironia, che apre il disco all'insegna del verbo roots rock che
in quegli anni si è impossessato di parte della scena alternativa americana, oppure
ancora la sua evoluzione in chiave elettrica e stentorea in Timing.
Nonostante tutto però il fascino di In the Spanish Cave, disco senza dubbio meno
sinuoso e assai più ruvido dei predecessori, risiede ancora nelle spirali di neo-psichedelia
che arroventano il suono in Red Sun, vero
fulcro e possibile capolavoro del disco, marchio della musica "desertica" della
band, da assaporare anche nella sua versione più onirica in Ring
e Astronomy.
Grazie
ad una delle copertine più prodigiose del periodo, In The Spanish Cave
è alternativamente considerato un punto di arrivo e un momento di passaggio nella
storia dei Thin White Rope (John Von Fledt è definitivamente il nuovo bassista,
mentre il batterista Josef Becker abbandonerà purtroppo a disco finito). In tutto
e per tutto pervaso dalla stessa impenetrabile bellezza dei primi lavori, il disco
ha tuttavia sofferto con il passare del tempo degli effetti di una produzione
frettolosa, segnata oltre misura da alcune delle manie da "big sound" tipiche
del periodo: lo stesso Paul McKenna di Moonhead siede in regia, ma insieme
alla band chiude il disco con un budget ristretto e soprattutto con il fiato corto
per il tour precedente. Da un certo punto di vista ne guadagna la compattezza
sonora accomulata sul palco, un monolite elettrico mai così efficace: In the Spanish
Cave contiene infatti alcune delle canzoni più crude del loro repertorio, che
diventeranno di fatto autentici cavalli di battaglia, a cominciare dalla rabbia
travolgente con cui Kyser aggredisce il clangore metallico di It's
Ok. Con quest'ultima formano un vero e proprio muro di suono la corsa
a rotta di collo di Elsie Crashed the Party,
anima punk che schizza come una scheggia impazzita lungo i feedback delle chitarre,
e ancora l'incedere blues sinistro di Wand.
Rappresentano nell'insieme gli episodi più di pelle, istintivi, di un disco che
espande invece alcune delle tematiche degli album precedenti con risultati inaspettati
per costruzione lirica e per sfumature degli arrangiamenti: non ti aspetteresti
ad esempio il caracollare country&western di Mr. Limpet
e la sua pungente ironia, che apre il disco all'insegna del verbo roots rock che
in quegli anni si è impossessato di parte della scena alternativa americana, oppure
ancora la sua evoluzione in chiave elettrica e stentorea in Timing.
Nonostante tutto però il fascino di In the Spanish Cave, disco senza dubbio meno
sinuoso e assai più ruvido dei predecessori, risiede ancora nelle spirali di neo-psichedelia
che arroventano il suono in Red Sun, vero
fulcro e possibile capolavoro del disco, marchio della musica "desertica" della
band, da assaporare anche nella sua versione più onirica in Ring
e Astronomy.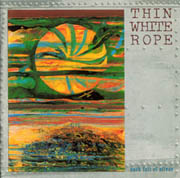 Come
sottolineano le stesse note interne al cd curate dal gruppo, Sack Full of
Silver è il primo lavoro dei Thin White Rope a germogliare "sulla
strada", con tutte le conseguenze che solitamente comporta una simile operazione.
Tuttavia, per nulla raffazzonato o schiacciato da esigenze di tempo (il produttore
è Tom Mallon, già al fianco degli American Music Club), l'album rappresenta un
momento di estrema maturità e concisione, in cui la band sembra fare tesoro del
proprio passato, per riassumere con rara e assoluta accuratezza il senso ultimo
del proprio stile. La lunga tournè mondiale dunque è servita a Guy Kyser e soci
per stratificare ulteriormente il rock di frontiera che soffiava polvere e desolazione
nei lavori precedenti, dando vita in Sack Full of Silver ad una splendida mediazione:
da una parte lo sperimentalismo, le trame psichedeliche e la "follia" ordinata
dei feedback (qui riassunti nella concisa riedizione di You
Doo Right dei Can e ancora di più nei tuoni elettrici di Diesel
Man), dall'altra, in netta prevalenza, l'afflato quasi neo-tradizionalista
che popola le nuove ballate di Kyser. Si sarebbe parlato al tempo di roots rock,
anche se non è sbagliato leggere in controluce nella meravigliosa e diafana title
track, con tanto di accordion, e più ancora nel cristallino folk rock di Americana
(un titolo premonitore) e On The Floe, o ancora
nella dolcissima maliconia di Triangle, le
avvisaglie della successiva rivoluzione chiamata alternative country. I Thin White
Rope abitano ancora la terra di nessuno del deserto americano, solanto questa
volta con una saggezza che li avvicina ai classici, come se Guy Kyser avesse scoperto
finalmente la voce del passato che lo chiamava dai luoghi oscuri americani (dell'anima
e del paesaggio, sempre così connessi nella sua scrittura). Disco di una bellezza
nostalgica, Sack Full of Silver è l'ultimo anello di una sequenza di capolavori
ignorati: avrà l'onore di una fugace prima distribuzione su major, prima di tornare
velocemente nelle mani della chioccia Frontier, dentro quella semi-oscurità a
cui il gruppo è stato destinato fin dal principio.
Come
sottolineano le stesse note interne al cd curate dal gruppo, Sack Full of
Silver è il primo lavoro dei Thin White Rope a germogliare "sulla
strada", con tutte le conseguenze che solitamente comporta una simile operazione.
Tuttavia, per nulla raffazzonato o schiacciato da esigenze di tempo (il produttore
è Tom Mallon, già al fianco degli American Music Club), l'album rappresenta un
momento di estrema maturità e concisione, in cui la band sembra fare tesoro del
proprio passato, per riassumere con rara e assoluta accuratezza il senso ultimo
del proprio stile. La lunga tournè mondiale dunque è servita a Guy Kyser e soci
per stratificare ulteriormente il rock di frontiera che soffiava polvere e desolazione
nei lavori precedenti, dando vita in Sack Full of Silver ad una splendida mediazione:
da una parte lo sperimentalismo, le trame psichedeliche e la "follia" ordinata
dei feedback (qui riassunti nella concisa riedizione di You
Doo Right dei Can e ancora di più nei tuoni elettrici di Diesel
Man), dall'altra, in netta prevalenza, l'afflato quasi neo-tradizionalista
che popola le nuove ballate di Kyser. Si sarebbe parlato al tempo di roots rock,
anche se non è sbagliato leggere in controluce nella meravigliosa e diafana title
track, con tanto di accordion, e più ancora nel cristallino folk rock di Americana
(un titolo premonitore) e On The Floe, o ancora
nella dolcissima maliconia di Triangle, le
avvisaglie della successiva rivoluzione chiamata alternative country. I Thin White
Rope abitano ancora la terra di nessuno del deserto americano, solanto questa
volta con una saggezza che li avvicina ai classici, come se Guy Kyser avesse scoperto
finalmente la voce del passato che lo chiamava dai luoghi oscuri americani (dell'anima
e del paesaggio, sempre così connessi nella sua scrittura). Disco di una bellezza
nostalgica, Sack Full of Silver è l'ultimo anello di una sequenza di capolavori
ignorati: avrà l'onore di una fugace prima distribuzione su major, prima di tornare
velocemente nelle mani della chioccia Frontier, dentro quella semi-oscurità a
cui il gruppo è stato destinato fin dal principio. Curioso
che a chiudere l'avventura in studio dei Thin White Rope sia forse il loro
disco meno sorpredente: tutto ciò non significa che con gli anni The Ruby
Sea non abbia riacquistato un fascino che al tempo era sembrato scolorirsi
di fronte alla bellezza spaventosa di Sack Full of Silver e In The Spanish Cave.
La band è nuovamente rivoluzionata nella sezione ritmica (Matthew Abourezk dietro
i tamburi, Stooert Odom al basso), forse incidendo sull'intesa immediata in studio
di registrazione: lavorando con Bill Noland (già al fianco di Stan Ridgway) i
Thin White Rope sembrano semplicemente fare tesoro delle conquiste del passato,
per la prima volta più "normali" del previsto, assecondando un suono che si è
fatto via via più monolitico, intensamente rock, ma dalle tinte scure, quasi gotiche,
spesso tralasciando il garbuglio chitarristico degli esordi. È quasi un disco
di frammenti, idee e intuizioni, spesso non perfette, ma capace di svelare angoli
nascosti, strane deviazioni di percorso, che qui prendono il titolo di Puppet
Dog, The Fish Song, sfiorando ancora
i sentieri della tradizione ma sfregiandoli nell'incedere di Tina
and Glen, dell'ubriaca Christmas Skies
o ancora di The Clown Song. La sfortuna di
The Ruby Sea è forse di non possedere la compattezza granitica di In The Spanish
Cave, né tanto meno le canzoni spericolate di Moonhead. È soltanto il ritratto
di un gruppo che ha raggiunto la una rappacificata maturità, può concedersi, per
quanto sia possibile applicare tale definizione ai Thin White Rope, di fare accademia
o più naturalmente di aspettare il raccolto migliore. In ogni caso non viene meno
il coraggio per l'ignoto: si chiama Dinosaur
ed è una specie di scheletro di canzone, qualcosa che approda al grado zero della
loro scrittura, una rarefazione del loro stile che fra una batteria e una tastiera
produce una eco lontana. Sarà anche l'ultimo segnale lanciato dal deserto del
Mojave verso l'infinito dell'universo, là dove idealmente risiedono i suoni e
l'immaginario del gruppo.
Curioso
che a chiudere l'avventura in studio dei Thin White Rope sia forse il loro
disco meno sorpredente: tutto ciò non significa che con gli anni The Ruby
Sea non abbia riacquistato un fascino che al tempo era sembrato scolorirsi
di fronte alla bellezza spaventosa di Sack Full of Silver e In The Spanish Cave.
La band è nuovamente rivoluzionata nella sezione ritmica (Matthew Abourezk dietro
i tamburi, Stooert Odom al basso), forse incidendo sull'intesa immediata in studio
di registrazione: lavorando con Bill Noland (già al fianco di Stan Ridgway) i
Thin White Rope sembrano semplicemente fare tesoro delle conquiste del passato,
per la prima volta più "normali" del previsto, assecondando un suono che si è
fatto via via più monolitico, intensamente rock, ma dalle tinte scure, quasi gotiche,
spesso tralasciando il garbuglio chitarristico degli esordi. È quasi un disco
di frammenti, idee e intuizioni, spesso non perfette, ma capace di svelare angoli
nascosti, strane deviazioni di percorso, che qui prendono il titolo di Puppet
Dog, The Fish Song, sfiorando ancora
i sentieri della tradizione ma sfregiandoli nell'incedere di Tina
and Glen, dell'ubriaca Christmas Skies
o ancora di The Clown Song. La sfortuna di
The Ruby Sea è forse di non possedere la compattezza granitica di In The Spanish
Cave, né tanto meno le canzoni spericolate di Moonhead. È soltanto il ritratto
di un gruppo che ha raggiunto la una rappacificata maturità, può concedersi, per
quanto sia possibile applicare tale definizione ai Thin White Rope, di fare accademia
o più naturalmente di aspettare il raccolto migliore. In ogni caso non viene meno
il coraggio per l'ignoto: si chiama Dinosaur
ed è una specie di scheletro di canzone, qualcosa che approda al grado zero della
loro scrittura, una rarefazione del loro stile che fra una batteria e una tastiera
produce una eco lontana. Sarà anche l'ultimo segnale lanciato dal deserto del
Mojave verso l'infinito dell'universo, là dove idealmente risiedono i suoni e
l'immaginario del gruppo. 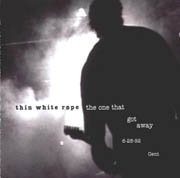 Il
sipario cala sulla storia dei Thin White Rope con un maestoso doppio disco
dal vivo registrato in un'unica serata: è lo show finale del 28 giugno 1992 tra
le mura del piccolo e infuocato club Democrazee di Gent, Belgio, a dimostrazione
una volta di più di quanto la band californiana sia stata accolta con tutti i
favori soprattutto dal pubblico underground europeo. The One That Got Away
può vantare una coesione eccezionale, senza abbellimenti e sotterfugi che ne modifichino
la struttura, ma semmai raccontino con cruda verità il "wall of sound"
chitarristico a cui la band è approdata nel corso del tempo. Ventisei canzoni,
due ore travolgenti su cui scorre uno strano senso di rabbia, un risentimento
malinconico in chi ha potuto scorgere la grandezza del gruppo in quell'istante
e non capacitarsi della quasi totale indifferenza: Kyser canta con una consapevolezza
della sconfitta che trascina con sé forza e sicurezza, come se il compito dei
Thin White Rope si fosse esaurito senza rimpianti. Ha ragione da vendere. Le verisoni
di Down in the Desert, Wire
Animals, Disney Girl e Astronomy
sembrano quelle definitive, portando a compimento la sintesi tra muscoli e cervello
della coppia di chitarre con Roger Kunkel, mentre l'ennesima sezione ritmica in
divenire (alla batteria ora siede per il tour europeo Stooert Odom) "devasta"
come una furia il repertorio. Qui le riletture di Take
It home e Triangle Song, o ancora
Tina and Glen paiono affermare l'ultima parola
sull'arte dei Thin White Rope, mentre la scaletta si arrichisce di sorprese e
chicche che saranno riservate alle varie raccolte di outtake: dal mazzo scegliamo
per la cronaca Some Velvet Morning, la dylaniana
Outlaw Blues, anche se l'imprevedile si annida
nella riproposizione di Roadrunner di Bo Diddley,
spogliata del beat originario e assai più sinistra, o ancora nel country rock
selvaggio del traditional Wreck of the Ol' 97.
Il
sipario cala sulla storia dei Thin White Rope con un maestoso doppio disco
dal vivo registrato in un'unica serata: è lo show finale del 28 giugno 1992 tra
le mura del piccolo e infuocato club Democrazee di Gent, Belgio, a dimostrazione
una volta di più di quanto la band californiana sia stata accolta con tutti i
favori soprattutto dal pubblico underground europeo. The One That Got Away
può vantare una coesione eccezionale, senza abbellimenti e sotterfugi che ne modifichino
la struttura, ma semmai raccontino con cruda verità il "wall of sound"
chitarristico a cui la band è approdata nel corso del tempo. Ventisei canzoni,
due ore travolgenti su cui scorre uno strano senso di rabbia, un risentimento
malinconico in chi ha potuto scorgere la grandezza del gruppo in quell'istante
e non capacitarsi della quasi totale indifferenza: Kyser canta con una consapevolezza
della sconfitta che trascina con sé forza e sicurezza, come se il compito dei
Thin White Rope si fosse esaurito senza rimpianti. Ha ragione da vendere. Le verisoni
di Down in the Desert, Wire
Animals, Disney Girl e Astronomy
sembrano quelle definitive, portando a compimento la sintesi tra muscoli e cervello
della coppia di chitarre con Roger Kunkel, mentre l'ennesima sezione ritmica in
divenire (alla batteria ora siede per il tour europeo Stooert Odom) "devasta"
come una furia il repertorio. Qui le riletture di Take
It home e Triangle Song, o ancora
Tina and Glen paiono affermare l'ultima parola
sull'arte dei Thin White Rope, mentre la scaletta si arrichisce di sorprese e
chicche che saranno riservate alle varie raccolte di outtake: dal mazzo scegliamo
per la cronaca Some Velvet Morning, la dylaniana
Outlaw Blues, anche se l'imprevedile si annida
nella riproposizione di Roadrunner di Bo Diddley,
spogliata del beat originario e assai più sinistra, o ancora nel country rock
selvaggio del traditional Wreck of the Ol' 97.
 Attività
a cui si sono sempre concessi volentieri, quella dell'ep è nella carriera dei
Thin White Rope quasi una necessità per agire da raccordo nella loro evoluzione
stilistica: spesso e volentieri si tratta di assolute gemme, per fortuna recuperate
nelle numerose ristampe su cd sia per la Demon europea, sia per l'originale etichetta
americana della Frontier. Popolati da cover illuminanti, inediti, outtakes, brani
che verranno poi rivisitati anche dal vivo, questi extended play possiedono la
magia per svelare la natura multiforme della band. Bottom Feeders,
ancora illuminato da un delizioso disegno di copertina che farà da collegamento
per la nave dei pirati di In the Spanish Cave, si apre con una spiazzante Ain't
That Lovin You baby, blues di Jimmy Reed trasformato in un rantolo
tra punk rock e Elvis Presley, e si chiude sulle note dal vivo di Rocket
Usa dei Suicide. Come dire: lo ying e lo yang del rock'n'roll. Il resto
sarà in parte recuperato nella scaletta di Moonhead (la sinuosa Waking
Up), alle cui atmosfere di straniante desert rock molto del materiale
rimanda: l'incedere honky tonk allucinato di Valley of
the Bones, altro omaggio malcelato a Johnny Cash, ma soprattutto il
diamante post punk di Atomic Imagery. Red Sun sarà se possibile
ancora più indicativo delle future direzioni della band: concepito inizialmente
come colonna sonora per uno stravagante film di avanguardia, un bianco e nero
la cui pellicola viene poi dipinta di arancione dando la sensazione alienante
e post-nucleare in cui si svolge la strampalata storia, l'album raccoglie una
versione acustica della title track, poi arrangiata per In The Spanish Cave, ma
soprattutto una serie di cover a dir poco esplicative, segnali per la svolta roots
di Sack Full of Silver. Si comincia con una improbabile Town
Without Pity, canzone dall'omonimo film con Kirk Douglas interpretata
da Gene Pitney e si finisce con la classica Some Velvet
Morning di Lee Hazlewood, qui schiacciata da tonnellate di feedback.
Nel mezzo la saga western di The Man with the Golden
Gun (da una colonna sonora di James Bond) e il capolavoro They're
Hanging me Tonight trata direttamente dall'indimenticabile Marty Robbins
delle Gunfighter Ballads. Squatter's Right del 1991 chiuderà questa
consuetudine di ep allineando una nuova serie di "inverosimili" cover, dalle quali
la band sembra attingere ispirazione e divertimento al tempo stesso: questa volta
tocca al'immortale Caravan di Duke Ellington,
una più prevedibile Roadrunner a firma Bo
Diddley, May This Be Love di Jimi Hendrix
(dal disco tributo If 6 was 9) e l'accoppiata Everybody's
Been Burned e I Knew I'd Want You
utilizzata per l'omaggio di band dell'area alternative rock ai Byrds, intitolato
Time Between. Una parte di questo materiale - in particolar modo l'intero ep Red
Sun - verrà recuperata nella scaletta di Spoor, classica compilazione
di inediti e rarità che nel 1995 la Frontier immette sul mercato colmando ormai
il silenzio della band, scioltasi due anni prima con l'epitaffio dal vivo The
One That Got Away. Prodotto per appassionati ed estimatori assuefatti dunque,
anche se le presenze di Outlaw Blues di Bob
Dylan e Burn The Flames di Roky Erckson, entrambe
ripescate dalla lunga moda di tributi sorta nei primi anni '90, sono appetitose
chicche che contribuiscono in fondo a chiarire una volta di più le coordinate
stilistiche e le isprazioni dei Thin White Rope. Quello che avanza è certamente
più trascurabile, fra brani dal vivo e demo che, aumetando la confusione, saranno
ripescate per una ristampa europea di Moonhead ad opera della Diablo.
Attività
a cui si sono sempre concessi volentieri, quella dell'ep è nella carriera dei
Thin White Rope quasi una necessità per agire da raccordo nella loro evoluzione
stilistica: spesso e volentieri si tratta di assolute gemme, per fortuna recuperate
nelle numerose ristampe su cd sia per la Demon europea, sia per l'originale etichetta
americana della Frontier. Popolati da cover illuminanti, inediti, outtakes, brani
che verranno poi rivisitati anche dal vivo, questi extended play possiedono la
magia per svelare la natura multiforme della band. Bottom Feeders,
ancora illuminato da un delizioso disegno di copertina che farà da collegamento
per la nave dei pirati di In the Spanish Cave, si apre con una spiazzante Ain't
That Lovin You baby, blues di Jimmy Reed trasformato in un rantolo
tra punk rock e Elvis Presley, e si chiude sulle note dal vivo di Rocket
Usa dei Suicide. Come dire: lo ying e lo yang del rock'n'roll. Il resto
sarà in parte recuperato nella scaletta di Moonhead (la sinuosa Waking
Up), alle cui atmosfere di straniante desert rock molto del materiale
rimanda: l'incedere honky tonk allucinato di Valley of
the Bones, altro omaggio malcelato a Johnny Cash, ma soprattutto il
diamante post punk di Atomic Imagery. Red Sun sarà se possibile
ancora più indicativo delle future direzioni della band: concepito inizialmente
come colonna sonora per uno stravagante film di avanguardia, un bianco e nero
la cui pellicola viene poi dipinta di arancione dando la sensazione alienante
e post-nucleare in cui si svolge la strampalata storia, l'album raccoglie una
versione acustica della title track, poi arrangiata per In The Spanish Cave, ma
soprattutto una serie di cover a dir poco esplicative, segnali per la svolta roots
di Sack Full of Silver. Si comincia con una improbabile Town
Without Pity, canzone dall'omonimo film con Kirk Douglas interpretata
da Gene Pitney e si finisce con la classica Some Velvet
Morning di Lee Hazlewood, qui schiacciata da tonnellate di feedback.
Nel mezzo la saga western di The Man with the Golden
Gun (da una colonna sonora di James Bond) e il capolavoro They're
Hanging me Tonight trata direttamente dall'indimenticabile Marty Robbins
delle Gunfighter Ballads. Squatter's Right del 1991 chiuderà questa
consuetudine di ep allineando una nuova serie di "inverosimili" cover, dalle quali
la band sembra attingere ispirazione e divertimento al tempo stesso: questa volta
tocca al'immortale Caravan di Duke Ellington,
una più prevedibile Roadrunner a firma Bo
Diddley, May This Be Love di Jimi Hendrix
(dal disco tributo If 6 was 9) e l'accoppiata Everybody's
Been Burned e I Knew I'd Want You
utilizzata per l'omaggio di band dell'area alternative rock ai Byrds, intitolato
Time Between. Una parte di questo materiale - in particolar modo l'intero ep Red
Sun - verrà recuperata nella scaletta di Spoor, classica compilazione
di inediti e rarità che nel 1995 la Frontier immette sul mercato colmando ormai
il silenzio della band, scioltasi due anni prima con l'epitaffio dal vivo The
One That Got Away. Prodotto per appassionati ed estimatori assuefatti dunque,
anche se le presenze di Outlaw Blues di Bob
Dylan e Burn The Flames di Roky Erckson, entrambe
ripescate dalla lunga moda di tributi sorta nei primi anni '90, sono appetitose
chicche che contribuiscono in fondo a chiarire una volta di più le coordinate
stilistiche e le isprazioni dei Thin White Rope. Quello che avanza è certamente
più trascurabile, fra brani dal vivo e demo che, aumetando la confusione, saranno
ripescate per una ristampa europea di Moonhead ad opera della Diablo.