|
|
|
inserito
24/09/2007
|
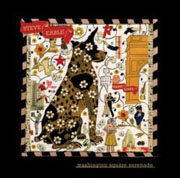
Steve
Earle
Che per Steve
Earle fosse giunta l'ora di un cambio di direzione era ormai evidente.
Assorbito da lotte e proclami politici, Steve aveva pubblicato negli ultimi
anni due dischi (Jerusalem
e The
Revolution Starts Now) che potremmo definire "funzionali alla
causa", dove l'urgenza di urlare i contenuti sovrastava la necessità di
dar loro anche una forma. Washington Square Serenade è dunque
il suo ritorno a casa dopo mille battaglie, tra le braccia dell'ennesima
nuova moglie (la bella country-singer Allison Moorer), e ad un folk ancora
più radicale che in passato, sempre più vicino allo spirito di Pete Seeger
(a cui è dedicata la sconclusionata Steve's Hammer) e sempre più
lontano dalla Nashville ingrata dei suoi anni ruggenti ("Goodbye Guitar
Town" canta nell'iniziale Tennessee Blues). Ma Washington Square
Serenade sarà anche "l'album delle batterie elettroniche", e qui starebbe
il passo avanti, l'azzardo modernizzatore di cui dovremmo parlare. Per
nulla avvezzo alla materia, Earle si è affidato al buon gusto del produttore
John King, uno che ha imparato a programmare basi per suoni rootsy
con un maestro nel genere come Beck, e che non a caso i Rolling Stones
chiamarono nel 1997 per svecchiare Bridges To Babylon. E King si dimostra
uomo intelligente, non cerca rivoluzioni strane, e abbina alle sue basi
meccaniche suoni di chitarra rudi e per nulla radiofonici, con un risultato
sonoro di grande impatto. Purtroppo però non sono le alchimie tecniche
che fanno di questo disco un episodio non del tutto risolto, ma i brani
stessi di Earle, a volte poco ispirati e convinti, così come le sue interpretazioni,
francamente frettolose e sottotono rispetto alla rabbia del passato. Così
se la bella sequenza centrale che dall'intensa ballad Come Home To
Me arriva alla distorta Red is The Color, passando per le classicissime
Jericho Road e Oxycontin Blues, ci riporta nei pressi del
pericoloso e rauco fuorilegge di un tempo, non convincono invece la cantilena
quasi rap di Satellite Radio o l'evanescente siparietto amoroso
con la moglie in Days Aren't Long Enough, che scompare se confrontata
agli incontri con Lucinda Williams e Emmylou Harris di una decina di anni
fa. Non decolla neppure la ricerca di un motivo orecchiabile in Down
Here Below, e soprattutto delude la brutta versione di Way Down
In The Hole di Tom Waits, un brano che vantava già rivisitazioni più
consone (quella di John Campbell su tutte). E se la giocosa Sparkle
And Shine (che piacerebbe a John Prine) rientra nella normale amministrazione
per uno come lui, lo spiazzante esperimento quasi etnico di City Of
Immigrants, una canzone contro il razzismo caratterizzata dai cori
del gruppo brasiliano Forro In The Dark, è da risentire e rivalutare
in quanto apre la porta a interessanti sviluppi futuri. Speranza che ci
conforta parecchio, perché la sensazione è che questo non sia il lavoro
di un artista arido e svuotato, ma sembra più un embrione di un nuovo
grande disco che deve ancora crescere. Vogliamo scommetterci?. |