|
|
|
inserito
19/03/2007
|
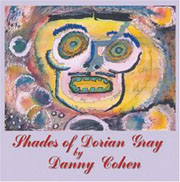
Danny
Cohen Potrei annoiarvi con lunghi
discorsi sul rapporto tra creatività e pazzia nel rock, potrei citare
a casaccio Syd Barrett, potrei diventare accademico e sciorinare i passi
che Kant ha dedicato all'argomento, concorde con il fatto che "genio e
follia si toccano da vicino" (Diderot). Ma qui ad annoiarci basta e avanza
la prosopopea del Signor Danny Cohen, uno che nella storiografia
rock passa per essere l'artista underground per eccellenza, talmente "under"
da esordire solo nel 1998 nonostante da più di quarant'anni illustri esponenti
dell'intelligenza rock lo acclamassero come "l'artista sconosciuto più
geniale", o se preferite la mai emersa "next big thing". Lui in verità
è uno strano personaggio vissuto all'ombra di veri geni (o veri folli?)
come Captain Beefheart, che giunge all'appuntamento con il terzo album
vero e proprio, considerando che i primi due dei cinque titoli della sua
discografia sono in verità raccolte di materiale sparso nel corso degli
anni. Shades of Dorian Gray, diciamolo subito, è un informe
ammasso di strambe/spocchiose/pretenziosamente intellettualistiche /falsamente
ironiche canzoni, 16 per la precisione, come già nei precedenti We're
All Gunna Die (2005) e Dannyland
(2004). La sensazione è quella di una persona normalissima che si atteggi
a pazzo genialoide nella speranza di imitare i suoi mentori Beefheart
e Tom Waits. Peccato che dei due il buon Cohen non abbia né il talento,
né tanto meno i mezzi. Spiace in un certo senso dover affossare così questo
disco, perché lo sforzo creativo di Cohen è sicuramente notevole, il tentativo
di crossover tra mille stili (si svaria tra folk, gospel, blues, i soliti
Brecht-Weill, qualche svicolamento verso il jazz avanguardistico alla
John Zorn, altro suo mecenate) testimonia la sua grande cultura musicale,
e forse anche perché i due album precedenti, seppur appesantiti dagli
stessi difetti, erano comunque apprezzabili. Qui invece si gioca a strabiliare,
ci si diverte ad infastidire, con la pretesa di farci sentire inadeguati
all'ascolto di tanta magniloquenza. Il problema non è essere irrimediabilmente
stonati (il timbro è quello di Jerry Garcia, la tonalità…lasciamo perdere…),
il problema è fare apposta a storpiare la voce come in The Fall
o la conclusiva Beneath The Shroud con effetti che lui vorrebbe
essere grotteschi, ma che finiscono per essere semplicemente sgradevoli.
Il problema è pretendere più di un ora della nostra attenzione per i suoi
testi irriverenti, i suoi arrangiamenti zoppicanti, i suoi canti strazianti.
Potrei anche dirvi che The Prophecy e For George Bailey,
LaPado and Bottom sono comunque dei brani di spessore, che non
tutto è da buttare, che qualcuno lo potrà anche trovare stravagantemente
"cool", ma non c'è più spazio, e soprattutto, da parte mia, non c'è più
la pazienza di scoprirlo. |